Tiaris
di Acuilee
Terre di Aquileia
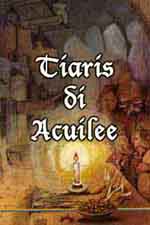 |
Curatori:
Massimiliano de Pelca - Maurizio Puntin - Luigi Del Piccolo
Collaboratori: Carla
Aita - Giacinto Avian - don Ottone Brach - Giuseppe
Bruni - Flavio Cossar - Luigi Deluisa
Ricercatori: Giampaolo
Chendi - Gianluca Comar - Matteo Cossar- Luigi Del Piccolo - Massimiliano de
Pelca - Enzo Macuglia - Gabriella Mesot - Adriana Miceu - Alessandro Pian -
Maurizio Puntin - Lucio Stel
Traduzione testi: Eliana
Merluzzi Barile
Consulente linguistico: Giancarlo
Ricci
Illustrazioni: Cesare
Spanghero |
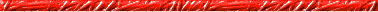
Leggende delle terre aquileiesi
MARZIO STRASSOLDO Rettore dell’Università di Udine
La cultura popolare trova una delle sue espressioni più
significative nel patrimonio di leggende in cui si riflette la molteplicità di
memorie che si stratificano nel tempo e si diversificano nella diversa sequenza
dei luoghi, caratterizzando in alcuni elementi fondamentali comportamenti e modi
di sentire di un popolo. La trasmissione orale di generazione in generazione
consente di acquisire elementi di conoscenza che nelle infinite varianti e
aggiunte permettono comunque di individuare alcuni frammenti delle esperienze
storiche attraverso le quali sono passate le comunità e alcuni collegamenti con
l’ambiente naturale e con quello costruito, con il quale esse si rapportano. L’area
nella quale sono stata raccolte le numerose leggende esposte in questo volume
presenta alcune specificità storiche ed ambientali di grande rilevo, che in
parte danno una giustificazione della frequenza e della natura di taluni
messaggi leggendari. Il primo elemento di specificità è costituito dall’ambiente
naturale dominato dall’acqua. Le risorgive, le fontane, i fiumi, le lagune
rappresentano l’aspetto dominante di questa realtà. È così non poteva che
assumere un ruolo evidente la sequenza delle leggende riguardanti le misteriose
creature viventi sul bordo o nell’ambito dei bojons, o delle lame, o delle
fontane, le aganis. Mentre in Carnia tali figure sono legate alle sorgenti e
alle grotte, e probabilmente anche nella loro versione di paganis richiamano
antichi abitatori di caverne, nella Bassa sono per lo più assimilate a
lavandaie notturne, a dispettose creature che entrano di notte nelle case
disturbando gli insonnoliti abitatori, e assai raramente note nella versione di
creature malefiche che afferrano chi si sofferma sulle sponde delle risorgive
per trascinarlo sott’acqua. Si tratta di lavandaie misteriose, di streghe
acquatiche, di sirene il cui elemento di caratterizzazione e di vita è
costituito dall’acqua viva che individua l’elemento naturale della bassa
pianura. Esse rappresentano probabilmente, come in montagna, il ricordo di
abitatori isolati, ritiratisi nel profondo delle selve paludose al riparo dei
pericoli costituiti dalla nuova religione che si estende sul territorio o dai
nuovi signori delle pianure e dei boschi, provenienti dal Settentrione o dall’Oriente
(da cui probabilmente la versione paganis, più frequente in montagna ma anche
registrata in alcune località della zona di San Giorgio). Esse talora si
confondono con lis fadis o falis, con lis striis e con lis òrculis, diffuse in
tutto il Friuli, soprattutto per quanto riguarda l’abitudine, indotta da chi
voleva liberarsene o tenerle occupate, consistente nell’invitarle nell’inane
attività di approvvigionarsi di acqua con un cesto di vimini. A queste creature
per lo più biancovestite, si aggiunge la sequenza delle streghe (striis), degli
orchi (orcui e anche òrculis) e di esseri di varia natura che di
notte si siedevano sui dormienti (cjalcjuts). Il secondo elemento di
specificità è costituito dalla presenza di Aquileia e dalla terribile vicenda
del passaggio di Attila, che ha lasciato tracce profonde e diffuse nella
fantasia popolare. Tutte le più note leggende sull’assedio della città
romana, sulla fuga dell’aquila, sulle devastazioni del territorio, sul suo
itinerario verso Concordia, Padova e Milano, sulla fuga degli aquileiesi nella
laguna (marinis), sulla sua sepoltura nel letto di un fiume, sui
sopralluoghi sul bordo della laguna e sulle località circostanti, sugli
innumerevoli tesori sepolti sia da Attila che da coloro che cercavano riparo
dalla ferocia degli Unni, trovano specifici riscontri in quasi tutte le
località considerate, sintomo di quanto la distruzione della grande città
fosse entrata nei secoli nella coscienza popolare. A queste leggende si possono
aggiungere quelle riguardanti i tesori (impressionante quella riguardante la
Chiesa di Sant’Andrea, Sant Andrât, di Perteole, dove nel corso dei
recenti restauri fu realmente trovata una "pignatta" piena di monete d’epoca
patriarcale), il passaggio di crociati a San Nicolò di Levata e di principi
tedeschi ad Aquileia, ancora legati agli immancabili tesori, le vicende di
antichissime chiese esistenti un tempo in laguna e in terraferma. Vi è poi la
serie numerosa di tradizioni e di leggende riguardanti animali fantastici,
spiriti, riti religiosi, santi, diavoli, conventi, mulini, fonti, pozzi.
castelli (Saciletto, Castions di Strada), ponti, villaggi e i loro abitatori
(frequente il richiamo agli apporti carnici). Non è questa certamente la sede
per un esame critico e per un’interpretazione dei processi di formazione, di
trasmissione e di elaborazione di questi elementi di conoscenza popolare. La
lettura di taluni testi fa emergere immediatamente la domanda se taluni brani
rispondono ad una antica elaborazione popolare o se si tratti di una ripresa di
elementi di conoscenza di origine dotta, quali talune leggende del ciclo
attiliano, la leggenda del crociato di San Nicolò di Ruda, ed altre. Si tratta
di interrogativi sui quali gli specialisti potranno esercitare tutta la loro
competenza critica per dipanare matasse di non certo facile soluzione. Ciò che
importa qui sottolineare è che gli autori hanno saputo raccogliere un
patrimonio di notevole ampiezza e interesse, fissando un complesso di brani
inediti che altrimenti si sarebbero irrimediabilmente perduti, data l’età di
molti informatori. Un segmento importante delle tradizioni popolari della Bassa
friulana è stato per questa via documentato e consegnato alle interpretazioni
degli studiosi, oltre che alla lettura di chiunque sia interessato alla storia e
alla cultura di questa terra.
Le fade vistude a neri
Una tempo si vedevano certe
cose... Ero bambina e avevo fame, perciò sono andata a casa a hiedere a mia
madre qualcosa da mangiare. «Non ti posso dare niente», ha detto mia
madre, «Va’ nel campo e mangia l’uva». E così sono andata nel campo
lungo la ferrovia, vicino ai casali dei Pantanali. Quando me ne sto
mangiando l’uva, sento un fischio: «Crederanno che stia rubando l’uva»,
ho pensato, «Ma... veramente sto sulla mia proprietà!». Sento altri due
fischi. «Ma che cos’hanno i Pantanali?», mi dicevo, «Non vedono che non
prendo l’uva del loro campo?». Il terzo... Vado verso il luogo da dove
provenivano i fischi. Nel prato di Dell’Olio c’è un gelso, e vi vedo
una donna seduta che si regge ad un ramo. Era vestita tutta di nero, con le
gambe a penzoloni e con i piedi lunghi ed appuntiti... anch’essi neri. Mi
guardava e mi spiava, di qua e di là dal ramo, facendo dondolare le gambe.
Mi sono fermata a guardare per un bel pezzo quella donna tutta nera. Mi
aveva fischiato perché la guardassi, e adesso non mi diceva niente...
Quella donna grande e tutta nera, che sicuramente era una fata, continuava a
guardarmi dondolando le gambe con i piedi appuntiti e facendo cucù di qua e
di là del ramo. Io non mi sono spaventata e, dopo averla guardata per un
bel po’, visto che non mi diceva niente, ho saltato il fossatello e mi
sono avviata verso casa. Quando ho percorso un bel tratto, pensando a quella
strana figura, mi sono decisa a tornare per guardarla di nuovo.
SAN GIORGIO DI NOGARO
30 - La fata
vestita di nero
 Une
volte si jodèvin da’ rubis... Jo ’o eri frute e ’o vevi fan: alore ’o soi lade
cjase a domandâj a mê mâri alc di mangjâ. «No ài nuje», ’sè mê mâri, «Va’ in
tal cjamp a mangjâ ue». E cussì ’o soi lade in ta chel cjamp tacât da ferade,
dongje dai cjasâi di Pantanali. Conch’o soi tal cjamp ch’o mangji ue, ’o sint
une sivilade. «E’ crodaran ch’o sedi a robâ ue», ’o ài pensât, «Ma... intant
jo ’o soi tal me!». ’O sint altris dôs siviladis. «Ma ze âno i Pantanâi?», ’o
disevi tra di mè, «Ma no jòdino che no cjôl le ue in tal so?». Le tiarze sivilade...
’O voi daûr di là ch’e àn sivilât. In tal prât di Dell’Olio al è un morâr, e
’o jôt une fèmine sintade su chist morâr che si ten sù sun dun branc. Chiste
fèmine ’e ere dute vistude a neri, cu li’ gjambis a pendolon e cui pîs luncs
e a spiz... ancje chei neris. Chiste fèmine mi cjalave e mi cucave, di ca e
di là dal branc, fasint dondolâ li’ gjambis. Mi soi fermade a cjalâ par un biel
toc chê fèmine dute nere. Mi veve sivilât par che le cjali e cumò no mi diseve
nuje... Chê fèmine grande e dute nere, ch’e jere di sigûr une fade, ’e cuntinuave
a cjalâmi dondolant chê’ gjambis cui pîs a spiz e fasint cucuc di ca e di là
dal ramaz. Jo no ài cjapade paùre e, dopo un toc che le cjalavi, judût che chê
fèmine no mi diseve nuje, ’o ài saltade le fuissute e mi soi inviade viars cjase.
Conch’o soi un biel toc indevant, pensant a chê strane figure, mi soi dizzidude
di tornâ a jòdile. SAN ZORZ
Une
volte si jodèvin da’ rubis... Jo ’o eri frute e ’o vevi fan: alore ’o soi lade
cjase a domandâj a mê mâri alc di mangjâ. «No ài nuje», ’sè mê mâri, «Va’ in
tal cjamp a mangjâ ue». E cussì ’o soi lade in ta chel cjamp tacât da ferade,
dongje dai cjasâi di Pantanali. Conch’o soi tal cjamp ch’o mangji ue, ’o sint
une sivilade. «E’ crodaran ch’o sedi a robâ ue», ’o ài pensât, «Ma... intant
jo ’o soi tal me!». ’O sint altris dôs siviladis. «Ma ze âno i Pantanâi?», ’o
disevi tra di mè, «Ma no jòdino che no cjôl le ue in tal so?». Le tiarze sivilade...
’O voi daûr di là ch’e àn sivilât. In tal prât di Dell’Olio al è un morâr, e
’o jôt une fèmine sintade su chist morâr che si ten sù sun dun branc. Chiste
fèmine ’e ere dute vistude a neri, cu li’ gjambis a pendolon e cui pîs luncs
e a spiz... ancje chei neris. Chiste fèmine mi cjalave e mi cucave, di ca e
di là dal branc, fasint dondolâ li’ gjambis. Mi soi fermade a cjalâ par un biel
toc chê fèmine dute nere. Mi veve sivilât par che le cjali e cumò no mi diseve
nuje... Chê fèmine grande e dute nere, ch’e jere di sigûr une fade, ’e cuntinuave
a cjalâmi dondolant chê’ gjambis cui pîs a spiz e fasint cucuc di ca e di là
dal ramaz. Jo no ài cjapade paùre e, dopo un toc che le cjalavi, judût che chê
fèmine no mi diseve nuje, ’o ài saltade le fuissute e mi soi inviade viars cjase.
Conch’o soi un biel toc indevant, pensant a chê strane figure, mi soi dizzidude
di tornâ a jòdile. SAN ZORZ

44. Li’ òrculis
cu li’ tamanis
Una volta di gnot a’
vignìvin sù li’ òrculis. A’ èrin femenati’ brutis che Di’
nus vuardi!, ch’a làvin atôr pal paîs, e s’a cjatàvin cualchidun
in zîr a’ vèvin cûr di partâlu a inneâsi. S’a cjatàvin puarti’
viartis, a’ làvin drenti ta’ cjasis e par chel and’era di chei ch’a
làvin a durmî cun tuna manaruta e la platàvin sot dal cussin. A’
disèvin che ’l basta al fiâr da manara par sfolmenâlis. Li’
òrculis a’ sirìvin par dut brincjêi e seglos par inneâ cualchidun,
ma la int, che li’ cognosseva za di tant timp, ’a lassava di fûr
apuesta dome tamanis (zeis). Alora li’ òrculis, che tristeria a’
vèvin tanta ma sarviel pôc e nuja, a’ cjapàvin sù li’ tamanis e
a’ làvin a cjoli aga ta roja. Pos crodi e setanti’ coretis via pa
gnot par emplâ chê’ tamanis di aga! Ma sul prin lusî dal dì li’
òrculis a’ sparìvin. FLUMISEL
Le orchesse con i panieri
Un tempo, di notte arrivavano le
orchesse. Erano talmente brutte che Dio ce ne scampi! Giravano per il
paese e, se trovavano qualcuno, avevano il coraggio di prenderlo e di
affogarlo. Se trovavano delle porte aperte, entravane nelle case;
perciò alcuni andavano a letto portandosi una piccola scure che
nascondevano sotto il guanciale: ritenevano che bastasse il ferro della
scure per farle fuggire. Le orchesse cercavano ovunque tini e secchi per
annegarvi la gente, ma questa, che le conosceva da tempo, lasciava
appositamente fuori di casa soltanto dei panieri. Perciò le orchesse,
piene di cattiveria ma con poco cervello, raccoglievano i panieri per
attingervi acqua nella roggia. Si può immaginare quante corse dovevano
fare durante la notte per riempirli d’acqua! E così, alle prime luci
dell’alba, le orchesse si dileguavano. FIUMICELLO

52
- L’òrcul di gnot
L’òrcul,
a dute gnot, al vosave pal paîs: «Jevait, jevait ch’e jè ore!...
’E jè ore di lâ a lavorâ in tai cjamps!». Ma no ere vere parzeche
nol ere ancjemò vignût dì. Le int, alore, che no veve orlòi e si
regolave cu le lûs dal soreli, ’e jevave, ’e cjatave incjemò scûr
e, bruntulant, ’e tornave in tal jet par colpe dal òrcul che ju veve
cjapâz in zîr.
PORPÊT
L’orco
di notte
In piena notte l’orco
andava gridando per il paese: «Alzatevi, alzatevi! È l’ora!... È
ora di andare al lavoro nei campi!». Ma non era vero, perché il giorno
non era ancora spuntato. I contadini allora, che non possedevano orologi
e si regolavano con il corso del sole, si alzavano, vedevano che eran
ancora buio e tornavano a letto, brontolando contro l’orco che li
aveva presi in giro.
PORPETTO

54
- L’òrcul e ’l bo
I vècjos
e’ contàvin che cuanch’e làvin jù pa Cjamane o in ta Culune cu li’
vacjis, cualchi volte a’ j capitave di cjatâ cualchi bo a passon,
senze paron. Alore, e’ contàvin, i contadins e’ distacàvin le
vacje dal cjâr e e’ tacàvin chel bo apene cjatât; ma, dopo vê fat
cualchi metro, chel bo al sparive! E, in tal stes moment, a’ sintìvin
une grande ridade: al ere l’òrcul che ju veve cjolz vie.
CJARLINS
L’orco e il bue
Raccontavano i vecchi
che, quando i contadini andavano al lavoro nella Cjamane o nella Culune,
incontravano talvolta un bue al pascolo, senza padrone. Staccavano
allora la mucca dal carro per sostituirla con il bue da poco trovato;
ma, dopo aver percorso soltanto qualche metro di strada, l’animale
spariva! Nello stesso istante udivano una grande risata: era l’orco
che li aveva presi in giro.
CARLINO
55
- I gjaz dispetôs
I
contadins di Cjarlins, par lâ tai cjamps di là da Ziline, e’ dovèvin
passâ pal punt dal Zes. Chist punt, in chê volte, nol ere cussì come
vuê. Il punt al ere plui alt e i cjârs, cjamâz, e’ fasèvin fature a
lâ sù, e, cuanch’e èrin parsore, i cjârs, finalmentri e’ podèvin
cori dirivinjù senze stracâ li’ vacjis. Une biele dì un contadin, cul
cjâr plen di ledan, a fuarze di dâj al è rivât a lâ sù. Cuanche il
cjâr al doveve cori jù dut sburît, invezzi si à fermât: sot dal cjâr
e’ èrin tanc’ gjaz che lu tignìvin fêr sclopant dal ridi. Chisc’
scherz e’ èrin simpri par colpe di chel dispetôs di òrcul.
CJARLINS
I gatti burloni
Per recarsi a
lavorare nei campi oltre il Zellina, i contadini di Carlino dovevano
attraversare il ponte del Zes. A quei tempi il ponte non era come oggi,
era molto più alto; perciò i carri stracarichi facevano fatica a
procedere in salita; ma, giunti in cima, potevano scendere dall’altr
parte senza sfiancare le mucche. Un giorno un contadino con il carro pieno
di letame, dopo molti sforzi, riuscì ad arrivare in cima; ma il carro,
quando poteva scendere veloce, rimase fermo: sotto di esso c’era un’infinità
di gatti che lo trattenevano ridendo a crepapelle. Questi scherzi erano
sempre dovuti a quel dispettoso dell’orco.
CARLINO

80
- La batela da’ striis
Al era ’na volta un pescjadôr
che di matina, cuanche ’l lava a cjoli la batela par lâ a pescjâ, no
la cjatava mai dulà che la veva mituda la dì prima, e ’a veva aga
dentri, come s’a fos stada doprada via pa gnot. Una biela dì si ’nd’à
stufât e si ’nd’à platât enfra ’l gavon da batela dulà ch’a
èrin li’ rês. Spieta che ti spieta, a nol rivava nissun, ma, tôr
miesagnot, eco vignî siet fèmini’ vecjis ch’a mòntin ta batela. La
plui vecja ’a taca a dî: «Alo par siet!», ma la barcja no si moveva.
’A torna a dî: «Alo par siet!», ma la barcja ’a restava ferma li (e
no podeva lâ indenant parvìa che cul pescjadôr a’ èrin invot). Alora
la fèmina ’a dîs di rabuf: «Alo par vot, alora!», e la barcja ’a
taca a cori jù pa l’Ànfura e dopo tal mâr. Fintramài ch’a son
rivâs in tuna tiara dulà che li’ fèminis a’ dismòntin. Al
pescjadôr, dopo vê spietât ch’a sèdin dismontadis dutis, al va jù
ancja lui e a’ si cjata a sei in tun puest bielon, plen di plantis, di
rosis e di pomis di ogni cualitât, e di lontan al riva a viodi li’
fèminis ch’a fasèvin fiestona insieme cun âtris. Chel al era al
famôs prât da Magansa. Paùra che lu òlmin che ’l era li, al torna
durman a platâsi ta batela, ma prima al cjôl sù una di chê’ rosis
bielonis che a’ cressèvin alì. Prin che ’l jevi al soreli, li’
siet fminis (ch’a èrin striis) a’ tòrnin su la batela. E la plui
vecja ’a taca a dî: «Alo par siet!». Ma la batela no si môf. Alora
la fèmina: «Alo par vot, alora!», e ’a dîs fra sè a plancut: «’A
no vares mai pensât che una di nô ’a fos in âtri stât, vecjis come
ch’e sin». E la batela si môf e ’a torna a fâ la strada di prima
fin a rivâ tal so puest ta riva dal flunc. Li’ vecjis a’ dismòntin e
si dìsin: «Ariviòdisi la gnot ch’a ven». Al pescjadôr, maraveât di
dut se che ’l veva viodût, tal doman di matina, di domenia, al va a
messa e si ponta su la camisola, dut sbraurôs, chel flôr che ’l veva
cjôt sù via pa gnot. ’Pena rivât su la puarta da glesia, una fèmina
lu ferma: «Alora tu eris tù l’otâf!», dissè, «Tu sês vignût cun
nô tal prât da Magansa, stagnot passada. Ricuàrditi di no pandi cun
nissun se che tu ’nd’âs viodût, se no tu varâs dome disgrassiis. E
buta via ancja chê rosa li, che nissun al devi savê ch’a esìstin
puesc’ compains». Al pescjadôr, di tanta paurona che ’l veva, a ’nd’à
fat come che ’nd’à diti la stria. E d’in chê volta nissun gi à
tocjâti plui la batela.
ACUILEA
La barca delle streghe
C’era una volta un pescatore che al mattino, quando
andava a prendere la barca per andare a pescare, non la trovava mai dove l’aveva
lasciata il giorno prima, e aveva dell’acqua dentro, come se fosse stata
adoperata durante la notte. Un bel giorno si è stancato e si è nascosto
dentro la prua della barca dove stavano le reti. Aspetta che ti aspetta,
non arrivava nessuno; ma, verso la mezzanotte, ecco giungere sette donne
vecchie che salgono sulla barca. La più vecchia esclama: «Avanti per
sette», ma la barca non si muove. Ripete: «Avanti per sette!», ma la
barca rimane ferma (e non poteva andare avanti per il fatto che con il
pescatore erano in otto). Quindi la donna esclama con tono di rimprovero:
«Avanti per otto, allora!», e la barca scivola lungo l’Anfora e poi
nel mare, finché arrivano in un luogo dove le donne scendono. Il
pescatore, dopo avere aspettato che fossero scese tutte, scende anche lui
e si ritrova in un posto bellissimo, pieno di piante, di fiori e di frutti
di ogni qualità, e da lontano riesce a vedere le donne che fanno una
grande festa insieme ad altre. Quello era il famoso prato della Maganza.
Per paura di essere scorto, subito si nasconde di nuovo nella barca, ma
prima raccoglie uno di quei bellissimi fiori che crescevano lì. Prima che
si alzi il sole, le sette donne (che erano delle streghe) ritornano sulla
barca. E la più vecchia dice: «Avanti per sette!». Ma la barca non si
muove. E la donna: «Avanti per otto, allora!», e dice piano fra sé:
«Non avrei mai pensato che una di noi fosse incinta, vecchie come
siamo». E la barca si muove e ripercorre il tragitto precedente fino a
raggiungere il suo posto sulla riva del fiume. Le vecchie scendono e si
salutano: «Arrivederci alla prossima notte». Il pescatore, meravigliato
per tutto ciò che aveva visto, il mattino seguente, di domenica, va alla
messa e si appunta sulla camicia, tutto borioso, il fiore che aveva
raccolto durante la notte. Appena giunto sulla porta della chiesa, una
donna lo ferma: «Allora eri tu l’ottavo!», dice, «Sei venuto con noi
nel prato della Maganza la notte scorsa. Ricordati di non confidare a
nessuno ciò che hai visto, altrimenti avrai soltanto disgrazie. E getta
via anche quel fiore, ché nessuno deve sapere che esistono posti
simili». Il pescatore, per la gran paura che aveva, ha fatto come gli
aveva detto la strega. E da allora nessuno gli ha più toccato la barca.
AQUILEIA

Al
batel da’ belandantis
81. Un
siart Siot al veva al so biel batel che di sera al leava atôr dal pâl
da riva dopo vêlu ben netât di dutis li’ scussis, di ben che gi
restàvin sul fons. Ogni matina, però, Siot tal so batel al cjatava alc
di gnôf. In principi nol veva bassilât plui di tant, ma un pôc a la
volta al veva finît cul stufâsi parseche gi pareva che di gnot
cualchidun al doveva doprâ al so batel. Impussìbil che ogni dì al
batel ’l fos peât cun grops diferens di chei ch’al faseva lui e che
su la prora a’ vèssin di sedi talpadis di pòlvar e cualchi volta
ancja di pantan. «Uli propi viodi», al scomensa a dî, «cui che ’l
è chel biel mòbil che mi fâs chê’ robis chi, che il diau’ lu
mangji!». Cussì, una sera, si veva platât tal mies da’ fassinis cu
la forcja in man par viodi sensa sedi viodût, e fâ e dî se che ’l
lava dit e fat. Dut in tun al veva viodût siet fantatis che, rivadis
dongja da riva, a’ èrin montadis tal batel, a’ vèvin dit alc che
Siot nol era rivât a capî e – orêso crodi? – al batel si veva
muvût sensa che nessuna di lôr ’a vedi vût tocjât i remps. Siot
’l era restât come un macaco. Al vares urût sigâ, ma la vôs no gi
vigniva, li’ gjambis gi clopàvin come doi vencs, la forcja gi veva
colâti fûr da man. La matina al batel ’l era là come ogni dì, ma
Siot dibot nol veva nancja coragjo di lâ via cun lui. A cjasa nol veva
dit nuja parseche gi varèssin dit che ’l veva clucât massa cuartins
di neri, cussì si veva tignût drenti chel biel grop e cumò gi pareva
di sclopâ. Al veva sirût di fâ l’indiferent e ’l veva tignût
dûr par cualchi ’sornada, ma nol podeva plui. Di sera nol podeva fâ
di màncul di lâ a platâsi tal fassinâr, al lava fûr cun tuna scusa
o chê altra e ogni sera ’a era la stessa berta. Chês a’ rivàvin,
a’ làvin tal batel e chist al partiva sensa che nissuna ’a ves
tocjât i remps. Siot al crodeva di doventâ mat e cussì al veva
dessidût di contâigi la roba al fi. «Vegni ben jo a viodi!», gi veva
dit chist ridint. Di sera ’l era lât cul pari e al veva viodût ancja
lui se che so pari al vedeva ’sa di un pies. «Orares propi savê
dulà ch’a van a chê’ oris chi e cui ch’a son!», al veva dit
Siot. Il fi, che ’l era vonda braurôs e che l’idea di còrigi daûr
a li’ fantatis no gi displaseva, al veva dit di sì. «Mi plati ben jo
tal batel doman di sera!», al veva dit, «E ’e viodarin cui ch’a
son e dulà ch’a van!». Dit e fat, tal doman di sera al fi di Siot si
veva platât ben e ’l veva scomensât a spietâ. A una siarta ora, li’
siet fantatis a’ vignìrin, a’ montàrin sul batel e chê ch’a
pareva la sorestanta ’a veva dit: «Via par siet!», ma ’l batel no
si veva muvût. «Gjoo, belandantis! Àja gnuvitâs cualchiduna di
vualtris, che par siet al batel no si môf?», ’a veva dit la sorestanta.
«Nancja par ideis!», a’ vèvin protestât dutis in coro
chê’ altris sîs. «Alora cualchidun si à platât sul batel!», ’a
veva dit chê ch’a veva fevelât par prima. Sîr che ti sîr, però,
no èrin rivadis a cjatâ cui che ’l era chel, e alora si vèvin
rassegnât. «Mah, alora via par vot!», ’a veva dit la capessa, e al
batel ’l era partît. Côr che ti côr, finalmente al batel si veva
fermât. Li’ fantatis a’ èrin dismontadis e al fi di Siot al veva
tirât fûr al cjâf dal cjanton che lu taponava e al veva scomensât a
cucâ atôr par viodi là che ’l era. Devant di lui ’l era un biel
prât plen di rosis di ogni cualitât e di duc’ i colôrs; si sintiva
una biela mùsica e chês fantatis a’ balàvin che ’l era un plasê
a viòdilis. Al zerbinot ’l era dismontât ancja lui da barcja, ma nol
veva vût coragjo di lâ tal mies di lôr; sensa fâsi viodi, si veva
contentât di cjoli un biel masset di rosis e dopo ’l era tornât tal
batel. Li’ fantatis a’ vèvin balât duta la gnot, e sul cricâ dal
dì a’ èrin tornadis tal batel; il fantat si veva platât indaûr.
Come tal lâ, ancja tal tornâ al batel si veva muvût domo disint:
«Via par vot!», e si veva fermât dongja dal pâl dulà che ’l stava
simpri. Li’ fantatis a’ èrin dismontadis e dopo un pôc ancja ’l
fi di Siot ’l era dismontât svelt, parseche nol vedeva l’ora di
contâigi dut a so pari. Al varà dovût contâ la storia dal vias e dal
bal a so pari no sai tropis voltis e, se nol fos stât par chel biel
masset di rosis, sì e no che Siot gi vares crodût. Tal doman ’a era
domenia, e al frutassat ’l era lât in plassa cu li’ rosis sul
cjapiel e duc’ gi li’ cjalàvin parvìa ch’a èrin propi bielis.
Dut in tun, però, cuant che al fantat al stava par contâigi a doi di
lôr la storia da gnot di prima, una fantata gi veva lâti dongja e gi
veva dit: «Ven ca ch’e vares alc di dîti!»; lu veva cjapât pa
mania da gjacheta e gi veva domandâti dulà che ’l veva cjolt chê’
rosis. Lui gi veva spiegâti dut e chê alora, cun tuna musa che no
prometeva nuja di bon, gi veva diti: «No sta’ a lâ mai plui ta chel
lûc! Tira jù al masset di rosis e... no sta’ a pandi a ànima
viventa chel che tu âs viodût. Âtu capît?». E ’a veva dit chisti’
ùltimi’ peraulis cun tun sest che ’l oreva dî muart sigura. Al
fantat nol veva sfladât; al veva tirât jù li’ rosis dal cjapiel e,
plen di paùra, ’l era lât a rinfrescjâsi in tuna frascja ch’a era
viarta su la plassa. Al veva capît ancja massa ben cui ch’a èrin li’
fantatis e se che ’l podeva tocjâigi se nol ves fat al mût lôr.
SARVIGNAN
Il
battello delle benandanti
81. Un
certo Ciot aveva il suo bravo battello, che di sera legava a un palo
sulla riva, dopo averlo ben ripulito delle scorie rimaste sul fondo.
Ogni mattina, però, vi trovava qualcosa di nuovo. All’inizio non vi
aveva badato più di tanto ma, con il ripetersi del fatto, aveva finito
con l’infastidirsi, perché gli pareva che di notte qualcuno usasse il
suo battello. Era incredibile che ogni giorno fosse legato con nodi
diversi da quelli che aveva fatto lui, e che sulla prua ci fossero delle
impronte di polvere e talvolta di fango. «Voglio proprio vedere», si
disse, «chi è quel bell’arnese che mi combina queste cose, che il
diavole se lo porti!». Così, una sera, si nascose in mezzo alle
fascine con la forca in mano, per vedere senza essere visto, e poi fare
e dire ciò che andava detto e fatto. Ad un tratto vide sette giovani
donne che, giunte presso la riva, salirono sul battello, dissero
qualcosa che Ciot non riuscì a capire e – ci credereste? – il
battello si mosse senza che alcuna di esse toccasse i remi. Ciot era
rimasto di stucco. Avrebbe voluto gridare, ma la voce non gli usciva; le
gambe gli tremavano come due giunchi, la forca gli era caduta dalla
mano. Al mattino il battello era di nuovo al suo posto come ogni giorno,
ma egli quasi non aveva il coraggio di adoperarlo. In casa non aveva
raccontato nulla perché gli avrebbero detto che aveva tracannato troppi
quarti di vino; perciò si era tenuto per sé quel groppo e gli pareva
di scoppiare. Aveva cercato di mostrarsi indifferente e c’era riuscito
per qualche giorno, ma non ne poteva più. Alla sera non poteva fare a
meno di nascondersi nella fascinaia, usciva di casa con una scusa o con
un’altra, e ogni sera si ripetevano le stesse cose: esse arrivavano,
salivano sul battello e questo partiva senza che nessuna toccasse i
remi. Ciot pensava di ammattire, perciò decise di raccontare tutto al
figlio. «Ci vado io a vedere!», gli rispose questi ridendo. E alla
sera vi andò con il padre e anche lui vide ciò che il padre vedeva
già da un pezzo. «Vorrei proprio sapere dove vanno a quest’ora e chi
sono!», commentò Ciot. Il figlio, che era piuttosto vanaglorioso e a
cui l’idea di seguire delle ragazze non dispiaceva affatto, annuì:
«Mi nasconderò io nel battello domani sera, e vedremo chi sono e dove
vanno!». Detto fatto, la sera del giorno seguente il figlio di Ciot si
nascose per bene nel battello e si mise ad aspettare. Ad una certa ora
vennero le sette giovani, montarono sul battello e quella che sembrava
la capitana disse: «Via per sette!», ma il battello non si mosse.
«Ehi, benandanti! Non sarà mica incinta una di voi, ché per sette il
battello non si muove?», esclamò. «Nemmeno per sogno!», protestarono
in coro le altre sei. «Allora qualcuno si è nascosto sul battello»,
disse quella che aveva parlato per prima. Cerca e cerca, non riuscirono
a trovare chi fosse e alla fine si rassegnarono. «Beh, allora via per
otto!», disse la capitana, e il battello partì. Corri e corri,
finalmente si fermò. Le giovani scesero e il figlio di Ciot sporse la
testa dal cantuccio che lo nascondeva e si guardò intorno per vedere
dove fosse. Davanti a lui si stendeva un bel prato coperto di fiori di
ogni genere e di tutti i colori; si udiva una musica piacevole e le
ragazze danzavano in un modo tale che era una gioia per gli occhi. Anche
lo zerbinotto scese dalla barca, ma non ebbe il coraggio di andare in
mezzo a loro; senza farsi scorgere, si limitò a cogliere un mazzetto di
fiori e si nascose di nuovo. Le giovani ballarono per tutta la notte e,
alle prime luci dell’alba, tornarono al battello, dove il figlio di
Ciot era rimasto rintanato. Come all’andata, anche al ritorno il
battello si mosse solo alle parole «Via per otto!», e si fermò
accanto al palo come sempre. Le giovani scesero e, dopo un po’, anche
il figlio di Ciot scese in fretta, perché non vedeva l’ora di
raccontare tutto al padre. Dovette ripetergli la storia del viaggio e
della danza un’infinità di volte e, se non fosse stato per il
mazzetto di fiori, probabilmente Ciot non gli avrebbe creduto. Il giorno
seguente era domenica e il giovanotto era andato in piazza con i fiori
sul cappello, e tutti li ammiravano perché erano davvero belli. Ad un
tratto, però, quando il giovane stava per raccontare a due amici la
faccenda della notte precedente, una ragazza gli si avvicinv e gli
disse: «Vieni qui, ché avrei qualcosa da dirti!». Lo tirò per la
manica della giacca e gli chiese dove avesse preso quei fiori. Lui le
spiegò tutto quanto e allora lei, con una faccia che non prometteva
niente di buono, gli disse: «Non andare mai più in quel luogo! Togliti
il mazzetto di fiori e... non rivelare ad anima viva quello che hai
visto. Hai capito?». Aveva pronunciato le ultime parole con un’espressione
che significava morte sicura. Il giovane non fiatò; tolse i fiori dal
cappello e, pieno di paura, andò a ristorarsi in un’osteria aperta
sulla piazza. Aveva capito fin troppo bene chi fossero quelle giovani e
che cosa sarebbe potuto capitargli se non avesse obbedito.
CERVIGNANO DEL FRIULI

La suriuta in bocja
95. A' cricava 'l dì ch'a si àn cjatât Meni e Jàcun, duc' i doi cu la falz
su la schena, la batadoria in man e 'l codâr daûr dal cûl. A' dovèvin lâ
a seâ un cuatri rivâi di fen, e sensa piardi timp e' àn cjapât la strada
ch'a va banda Strassolt e, passât al Pajanic, sùbit dopo la strada di Nauac,
and'àn voltât a man sampa par una straduta ch'a menava là ch'a vèvin i
rivâi di seâ: di chê' bandis dal Pizzat o da Gurissizza, par capîsi.
Finût di seâ che 'l soreli al era za ben in alt, e' àn disvuedât al codâr,
siarât la falz e a' si àn mitût a cjaminâ, tabajant, banda cjasa. Dopo fat
un pocja di strada a' viòdin, di lontan, un so copari che, finût ancja lui
di seâ, al si veva indurmidît sun tun marel di fen sot un sterp di onâr; e
co a' son rivâs a cuatri pas di lui, che 'l durmiva ancjamò, a' ti viòdin
una suriuta blancja ch'a coreva sul sei di fen e cun tun salt j jè lada in
bocja e lui si à sveât. Meni e Jàcun j àn contâti sùbit ch'e àn viodût
una suriuta blancja a lâj in bocja e lui j à rispundûti: "Chê suriuta
li 'a jè vignuda di Nauac, là ch'a era lada a partâ malans in tuna famea".
Nol era ancjamò 'l soreli a mont che in ta chê famea a' j èrin za rivâs
dongja malans in cjasa e ta stala, e e' àn vût se scombati a lunc prin di
fermâ chei malafizzis. UANIS
Il topolino in bocca
95. Incominciava a fare giorno quando si incontrarono Domenico e Giacomo,
entrambi con la falce sulle spalle, l'incudinetta in mano e il corno della
cote alla cintola. Dovevano andare a falciare alcuni ciglioni, e senza perder
tempo imboccarono la strada che porta a Strassoldo e, oltrepassato il Pajanic,
subito dopo l'incrocio per Novacco voltarono a sinistra per una stradina che
portava ai ciglioni da falciare: dalle parti del Pizzat e della Goricizza,
tanto per intenderci. Terminato il lavoro quando il sole era ormai alto,
vuotarono il corno, riposero la falce e si incamminarono, chiacchierando,
verso casa. Percorso un tratto di strada, videro da lontano un loro compare
che, avendo anch'egli finito di falciare, si era addormentato su di un mucchio
di fieno sotto un cespuglio di ontano; e quando giunsero a quattro passi da
lui, che ancora dormiva, videro un topolino bianco correre sul bordo del
mucchio e con un salto entrargli in bocca, e lui si svegliò. Domenico e
Giacomo gli raccontarono subito di aver visto un topolino bianco entrargli in
bocca, ed egli rispose: "Il topolino veniva da Novacco, dove era andato a
portare disgrazie in un famiglia". Non era ancora tramontato il sole che
in quella famiglia capitarono delle disgrazie in casa e nella stalla, ed
ebbero il loro bel da fare per allontanare quei malefici. JOANNIS

I lôfs ch'a ùrlin
100. Chiste fèmine, d'in chê dì che si veve sposât 'a no à vude pâs. E'
vèvin le cjase gnove, 'pene screade, e 'e àn cjatât dut un grun di cjavêi
tal spargher gnôf. No àn plui stât ben. Alore a' son lâs là dal plevan a
viodi se che è chê robe li. El predi j à diti: "Magaricussinò, ti l'àn
petade in chel dì che tu sês sposade. Cjapait el cussin là ch'e duâr le
fèmine, e vait sun tune crosade e lu brusais". E' son lâs su le crosade
fra San Vît e Crauì, di gnot, el marît de fèmine e 'l cugnât. Cuanche
cjapave fûc el cussin, e' son saltâs fûr trê lôfs urlant. E dopo e' àn
sintût une vôs a dî: "'E sin plui fuars di vuâtris! 'E sin plui fuars
di vuâtris!". Alore i ons, plens di paùre, a' son scjampâs a cjase. E
chê pùare zòvine no à condurât tant: 'a è muarte dopo cualchi mês.
VISCON
I lupi che ululano
100. Una donna, dal giorno in cui si era sposata, non aveva più avuto pace.
Avevano la casa nuova, appena inaugurata, e vi trovarono un ciuffo di capelli
nella nuova cucina a legna. Non sono più stati bene. Si recarono dal parroco
per vedere di che cosa poteva trattarsi. l prete disse: "Così non fosse,
ma ti hanno gettato il malocchio il giorno che ti sei sposata. Prendete il
guanciale dove dorme la moglie, andate su di un crocevia e bruciatelo".
Andarono su un crocicchio fra San Vito e Crauglio, di notte, il marito della
donna e il cognato. Quando il guanciale stava prendendo fuoco, ne sono balzati
fuori ululando tre lupi. E poi udirono una voce che diceva: "Siamo più
forti di voi! Siamo più forti di voi!". Allora gli uomini, spaventati,
fuggirono a casa. E la povera ragazza non durò a lungo: morì dopo qualche
mese. VISCONE

Le vacje cu le muse di on
101. Une volte un on dal paîs j à dit a un âtri: "Ventu cu le tô
vacje a dâmi une man a solzâ le vigne?". "Eh...", al à
rispundût chel âtri, "no pos vignî, sâtu...". Il prin on al veve
insistût parzeche, si jôt, al veve propi dibisugne, ma il secont al veve
tornât a dî che nol podeve pròpite lâ. Alore, stufât, il prin on j à dit:
"Tù no tu pos vignî par mè, ma no tu larâs nancje par nissun âtri!".
Tal doman le vacje s'inmale e a cause di chê bramazzion no rive plui a jevâ
sù. I ùltins dîs, prime di murî, cuanche si entrave drenti in ta stale, le
vacje, ch'e ere distirade, si voltave a cjalâ cu le muse di un on. E'
contàvin ch'e ere inpressionante cun chê muse: 'e ere pròpite come chê di
chel on che le veve maludide! VILIGNOVE
La mucca con la faccia da uomo
101. Una volta un uomo del paese chiese ad un altro: "Vieni con la tua
mucca a darmi una mano a sarchiare la vigna?". "Beh... ",
rispose l'altro, "non posso venire, sai...". Il primo insistette
perché, evidentemente, ne aveva proprio bisogno, ma il secondo ripetè che
non ci poteva proprio andare. Allora, seccato, il primo disse: "Tu non
puoi venire per me, ma non andrai neanche per nessun altro!". Il giorno
seguente la mucca si ammalò e, a causa di quel malaugurio, non riuscì più
ad alzarsi. Gli ultimi giorni prima di morire, quando si entrava nella stalla,
la mucca, che stava distesa, si voltava a guardare con la faccia di un uomo.
Dicevano che fosse impressionante con quel viso: era proprio quello dell'uomo
che l'aveva maledetta! VILLANOVA

Le pavee dal strion
104. Une dì el barbe di mê agne, ch'al durmive cu le bocje viarte, in chê
matine no si rivave a sveâlu: lu clamàvin e lu sdrondenàvin, ma nuje ce fâ.
Fintramài che dal barcon 'a jè vignude une pavee, e chê j è entrade in
bocje. Come che chê j è entrade drenti in bocje, el barbe di mê agne si è
sveât e, dut content, al à dit: "Usgnot 'o soi stât a morosâ in
Gjermanie cu le mê vecje morôse". I sìe no j àn crudût ma lui al à
zurât ch'e jere vere! E' vuèlin dî che ziarte int 'e nas cun tune fuarce
ch'e pòdin fâ ancje rubis ch'e samein impussìbilis. GONÂRS
La farfalla dello stregone
104. Una mattina lo zio di mia zia, che dormiva con la bocca aperta, non c'era
verso di svegliarlo: lo chiamavano e lo scuotevano, ma niente da fare. Finché
dalla finestra venne una farfalla che gli entrò in bocca. Come gli entrò in
bocca, lo zio di mia zia si svegliò e, tutto contento, disse: "Stanotte
sono andato a far l'amore in Germania con la mia vecchia amorosa". I suoi
non gli credettero ma lui giurò che era vero! Dicono che certuni nascano con
un potere che permette loro di fare delle cose che sembrano impossibili.
GONARS

Il bal da' striis
111. Al ere me pari ch'al contave chistis storiis cun dun mût che nus faseve
restâ, nû fruz, duc' a bocje viarte. 'A ere une fameje cun dôs fiolis
grandis. Une das dôs 'a morosave cun dun zòvin, e j oreve ancje ben, ma a le
sere, conch'a rivave une ziarte ore, le morôse, ma ancje chês altris, lu
mandàvin simpri vie. E dàj une sere e dàj chê âtre, il morôs a un ziart
punt al à dite: "Ma cjale, ogni sere a chê ore mi màndin vie... Epûr
une sere 'e ài di stâ atent a ze ch'e fàsin". E une sere si è mitût
di impegno: al à fat fente di lâ vie e par chel barcon dal seglâr che lu
tignìvin simpri in sfêse, parzeche 'a ere siarade le puarte, no?, al à
judût li' trê fèminis ch'e cjapàvin un pignatin, si onzèvin e, une a le
volte, si metèvin sot le nape. Prime le mari: "Burububù, tìrimi sù!",
'sè, e op... che le mari 'a ere lade sù pal camin! Subit dopo 'a ere lade
chê zòvine: "Burububù, tìrimi sù!". E vie ancje jê sù pal
camin. Podopo 'a ere lade le tiarze. Sichè e' èrin ladis sù pal camin le
mari cun chistis dô' fiolis. In tal doman di sere il morôs al fâs fente di
lâ a morosâ, come se nol ves judût nuje, e dopo che, come il sòlit, a une
ziarte ore che lu vèvin mandât vie, "Spiete, spiete...", 'sè;
"Cumò j a le peti ben biele jo!", dissè. Al à spietât che dutis
si vèdin onzût e, conche dutis trê e' èrin ladis sù pal camin, al à
cjapât e al è lât drenti ancje lui. "'Pete, 'pete... Bisugne ch'e fasi
ancje jo compaign, no?". Al si ere ancje lui ont cun chel unzint dal
pignatin, al si ere mitût sot dal camin e...: "Burububù, tìrimi sù!",
al ere lât sù ancje lui. E disore là si jôt ch'a ere come une sale, un
grant cjast o une di chê' mansardis... come chês, si viôt, che e' èrin une
volte, no?... E, insome, 'a ere une grande fiêste! E' cjantàvin, e' balàvin,
e' saltàvin e in ta chiste grande fieste e' èrin ancje lôr... Se nol è, le
mari lu veve lampât: "Orpo!", dissè. Alore 'a veve cjapât li'
fiolis, e chês e' vèvin dit: "Orpo! E cumò zemût vino di fâ?".
E' balàvin ancje lôr, no? 'L à cjapât sù, 'l è lât dongje e j à dit:
"Bon, bon", dissè, "'A vevis reson vuâtris ogni sere di
mandâmi vie! 'A vevis ze fâ ca, vuâtris, a divirtîsi!". "E
zemût âtu fat?", j àn dit. "'E ài fat come ch'a vês fat
vuâtris!", dissal. E cussì e' àn scugnût cjapâsi sù e radunâsi,
duc' cuanc', e... insome, e' àn gjuldût cussì, duc' insieme, chiste fieste.
CJARISÀ
Il ballo delle streghe
111. Mio padre raccontava queste storie in un modo tale che noi bambini
restavamo a bocca aperta. C'era una famiglia formata da una madre e due figlie
adulte. Una delle due era fidanzata con un giovane al quale voleva molto bene,
ma, nonostante ciò, ad una certa ora della sera, tanto lei che le altre donne
lo mandavano via. Dàgli una volta, dàgli un'altra, il giovane si disse:
"Ma guarda un po'! Ogni sera ad una certa ora mi mandano via... Ebbene,
prima o poi voglio coprire che cosa fanno". E una sera ci si mise
d'impegno: finse di andarsene e, attraverso la finestrella del retrocucina che
rimaneva sempre socchiusa, vide le tre donne prendere un pentolino, ungersi
con il contenuto e, una alla volta, mettersi sotto la cappa del camino. Per
prima si sistemò la madre, che disse: "Burububù, tirami sù!". E
op... su per il camino! Di seguito toccò alla sua fidanzata: "Burububù,
tirami sù!". E via anche lei su per il camino! Poi andò la terza. E
così volarono attraverso il camino la madre e le due figlie. La sera seguente
il giovanotto si ripresentò come se non avesse visto niente n casa della sua
fidanzata e aspettò che, come al solito, a una certa ora lo mandassero via.
Disse tra sé: "Aspetta, aspetta... Ora gliela combino bella!".
Attese che si ungessero e, dopo che, una alla volta, furono salite magicamente
per il camino, entrò in casa. "Aspetta, aspetta... Dovrò fare anch'io
come loro!". Si unse con l'unguento del pentolino, si mise sotto la cappa
del camino e...: "Burububù, tirami sù!". E ci salì anche lui!
Lassù c'era una specie di salone, un grande granaio o una mansarda come si
usava una volta... Insomma in quel posto c'era una grande festa! Cantavano,
ballavano, saltavano, e tra questi gaudenti c'erano anch'esse... Ma ad un
certo punto la madre lo scorse e disse: "Capperi!". Avvertì le
figlie che stavano ballando e queste dissero: "Capperi! E ora che
facciamo?". Il giovanotto si avvicinò alle tre donne e osservò:
"Bene, bene! Facevate bene a mandarmi via ogni sera! Qui sì che ci si
diverte, eh?". "Ma come hai fatto a venire fin qui?", gli
chiesero. "Ho fatto come avete fatto voi!", rispose. E così,
volenti o nolenti, tutti insieme si sono goduti quella strana festa.
CHIARISACCO

El cjalcjut presonêr
113. Conche un frut al nas cu le placente da le mari ancjemò tacade, a' si
dîs che chel frut al è nassût cu le cjamese. Chist, però, al suzzêt da
râr. Ben, chel frut che 'l nas cussì di grant al pos vî dai podês
straordenaris. l pos rìndisi invisìbil o doventâ une bestie par podê
passâ pa li' fressuris di une puarte o barcon e jentrâ, cussì, ta li'
cjasis. Chist on, strion, al è 'l cjalcjut. El cjalcjut al va di gnot a fâ
tribulâ cui che 'l ûl lui. Al va a fracâj le panze o el stòmit fin a
lassâ senze flât chê persone che 'l à sielt. E alore par podê savî cui
che 'l è chel cjalcjut, e par cjapâlu, bisugne che chel che 'l à patît le
sô prisinze, in tal moment che 'l si svee al scugni fâ svelt le pipì in
tune butilie e taponâle subit. El cjalcjut, cussì, al reste presonêr in ta
le butilie e al è costret a fâsi cognossi, a domandâj perdon e a preâlu
par plasê che lu meti in libertât. SARVÂS
L'incubo nella bottiglia
113. Quando un bimbo nasce con la placenta attaccata, si dice che è nato con
la camicia. Questo fatto, però, succede raramente. Ebbene, il bimbo che nasce
in questo modo da adulto potrà avere dei poteri straordinari. Potrà rendersi
invisibile o tramutarsi in animaletto per poter entrare nelle case attraverso
la fessura di una porta o di una finestra. Costui, una specie di stregone, è
l'incubo. L'incubo va di notte a tormentare chi vuole: opprime la pancia o lo
stomaco di chi ha scelto fino a lasciarlo senza fiato. Per riuscire a sapere
chi è e per catturarlo, bisogna che chi è stato sottoposto alla sua tortura,
nel momento del risveglio, faccia immediatamente la pipì in una bottiglia e
la tappi subito. L'incubo, così, rimane prigioniero ed è ostretto a
rivelarsi, a chiedere perdono e a pregare la sua vittima di ridargli la
libertà. SAN GERVASIO

Le spie di forment
120. Me nono al contave che al veve simpri el cjalcjut. Al are unviâr e 'l
jet al are plen di coltris. Me nono al procurave di stâ veât par cuanch'al
vignive el cjalcjut e, cuanche lu à sintût e ch'al à scomenzât a
sfrechejâlu, 'l à cjapadi' li' cujartis, lis à fatis sù intôr dal
cjalcjut e al à scomenzât a dâj jù cui pùins e cui zenôi. El cjalcjut,
drenti in ta cujarte, al vuicave e al diseve: "Làssimi, làssi-mi!...";
e cuanche me nono al è stufât di dâj j à dite: "Tu âs di dîmi cui
che tu sês e jo ti lassi". Ma nissun 'l à dit plui nuje. Alore me nono
'l à disgropât li' cujartis e drenti 'e are restade sôl une spie di forment.
Si viôt che el cjalcjut, sintût ch'al are in tràpule, si à trasformât in
spie di forment par no fâsi cognossi; ma tal doman al are pal paîs un dut
fassât e plen di botis! GONÂRS
La spiga di frumento
120. Mio nonno diceva di avere sempre l'incubo. Era d'inverno e il letto era
carico di coltri. Mio nonno cercava di rimanere sveglio per attendere l'incubo
e, non appena lo sentì incominciare a premergli il petto, afferrò le
coperte, gliele avvolse intorno e prese a colpirlo con i pugni e con le
ginocchia. L'incubo, in mezzo alle coperte, gridava e diceva: "Lasciami,
lasciami!..."; e mio nonno, quando si stancò di picchiarlo, gli disse:
"Dimmi chi sei e io ti lascio". Ma non ci fu alcuna risposta. Allora
il nonno sciolse le coperte e vide che vi era rimasta soltanto una spiga di
frumento. Evidentemente l'incubo, sentendosi intrappolato, si era trasformato
in una piga di frumento per non farsi riconoscere; ma il giorno dopo girava
per il paese un tale tutto fasciato e pieno di lividi! GONARS

I spirs malins a Merêt
134. In tune famee di contadins a Merêt di Cjapìtul e' sucedèvin robis
brutis. E' èrin in tredis in famee, e e' dovèvin lâ a durmî sul cjast
parceche te' cjàmaris a' èrin spirz malins che ju tormentàvin. E'
sdrondenàvin i jez, ju tiràvin pai pîs... insome no si podeve stâ te'
cjàmaris. Sul cjast invessi e' podèvin passâ le' gnoz, ma a' èrin sfinîz
a fuarze di durmî su li' breis, e e' vèvin ancje tante pôre parcech'e
disèvin: "Ca, dulà nino a finîle? Ce demoni sàltie' fûr?". E'
àn diti al plevan di Sante Marìe, ch'al è vignût ma nol à pudût fâ nie.
Alore e' àn diti al onsignôr di Palme, ch'al ere innomenât tant. E 'l è
vignût chist predi e 'l è lât in cjase. Su le strade 'a ere tante int di
Merêt e ancje di fûr. E' àn sintût sberlâ el predi. E dopo si sintìvin
vosatis, si sintive uicâ e urlâ come ch'e fàsin i lôfs. El predi 'l à
tant scunzurât e ju à mandâz su le mont Cjaline [Cjanine]. "No!",
e' àn dit chei, "Là nol è puest par nô!". "Sì, là 'o vês
di lâ; le mont Cjaline 'e jè par vuâtris!". Parceche dopo il Concili
di Trent, i danâz e i spirz malins e' son stâz mandâz duc' su le mont
Cjaline. Là e' dovèvin sbrocâsi su li' pieris, leâz cun grandis cjadenis,
in ta chei zòndars là sù. Insome une pôre ti veve chiste pùare int a
sintî cussì! E dopo cualchi ore 'l è vignût jù el pùar predi, e 'l ere
dut bagnât di sudôr, ancje le vieste, e strac muart. E 'l à dite: "Jo
'o ài fat le mê part dal miò dovê, 'a ju ài iliberâz. Cumò i spirz
malins e' son lâz. Ma a mì mi tocjarà di murî". Vot dîs dopo al è
muart. MERÊT DI CJAPÌTUL
Gli spiriti malign a Mereto di Capitolo
134. In una famiglia di contadini, a Mereto di Capitolo, accadevano delle
brutte cose. Erano in tredici in famiglia, e dovevano ndare a dormire nel
granaio perché nelle camere c'erano gli spiriti maligni che li tormentavano.
Scuotevano i letti, li tiravano per i piedi... insomma non potevano rimanere
nelle camere. Nel granaio, invece, potevano trascorrere la notte, ma erano
sfiniti a forza di dormire sulle tavole, e avevano anche una gran paura.
Dicevano: "Dove andremo a finire? Che demonio ne verrà fuori?".
Chiamarono il parroco di Santa Maria, il quale venne ma non poté far nulla.
Allora chiamarono il monsignore di Palmanova, che era tanto famoso. Questo
prete venne ed entrò in casa. Fuori, sulla strada, c'era molta gente di
Mereto ed anche di altri paesi. Udirono il prete gridare. E poi sentirono
delle voci orribili, si sentiva guaire e urlare come fanno i lupi. Il prete li
esorcizzò e li mandò sul monte Canin. "No!", dissero gli spiriti,
"Quello non è posto per noi!". "Sì, là dovete andare; il
monte Canin è per voi!". Dopo il Concilio di Trento, i dannati e gli
spiriti maligni vennero mandati tutti sul monte Canin. Là dovevano sfogarsi
sulle pietre, legati con grosse catene, nelle caverne che si trovano lassù.
Insomma, quella povera gente provò una gran paura sentendo questo. Dopo
qualche ora scese il povero prete, tutto bagnato di sudore, compresa la onaca,
e stanco morto. E disse: "Io ho fatto la mia parte, com'era mio dovere, e
li ho liberati. Ora gli spiriti maligni se ne sono andati. Ma io dovrò
morire". Una settimana dopo morì. MERETO DI CAPITOLO

Al diaul e ’l sartôr
153. Jàcun
al era ’l sartôr dal paîs e’l veva simpri un grun di lavôr paroìa che
nol veva lavoranz e nancja garzons intôr, sicheduncja j tocjava fâ dut di
bessôl: tajâ, imbastî, ingasiâ, ribati, fâ sorapont, sopressâ, misurâ; in
pocjis peraulis al faseva pròpit dut. Sintât su la sô cjadrea, cun tun pît
pojât sul spiàrgul e chel altri parsora di un scagnut, pleât come un buinz
sul sô lavôr, al cusiva fis sensa riardi timp. J plaseva mètisi dongja dal
barcon, un pôc parseche alì al vedeva miôr, parvìa dal clâr, e un pôc
parseche ogni tant al dava un cuc fûr, sul plassâl, a cui ch’al passava par
li. Cu la biela stagjon al lassava viart al barcon, cussì ogni tant cualchi
cugnussint al vigniva a sintâsi su la plana par fâ una partida di discors. A
Jàcun j plaseva sintî li’ gnovis dal paîs e fevelâ di chist e di chel
âtri, ma biel cjacarant o biel scoltant al lava dilunc instes a impirâ e
dispirâ la fusela cu lis sô’ glains, par lâ indevant tal sô lavôr. Una
dì di instât, sot gnot, al ven a sintâsi su la plana dal barcon nuja màncul
che ’l diaul. Cjapât tal sô lavôr, Jàcun no si scompon pi di tant, cussì
al diaul al si met a cjalâ fis, sensa nancja sfladâ, in se maniera che Jàcun
al lavorava. Jàcun, par dî la veretât, al veva una primura mostra, parvìa
che ’l veva di finî una gjacheta par tal doman; e cussì, sensa mai tirâ sù
i vôi da’ cusiduris, al impirava svelt la gusela e ’l pesseava a dâ pons
daurman; podopo, finida la glain, la tajava cui dinc’, al dispirava ’l tucut
vansât, al faceva un’âtra glain, la impirava ta gusela e via a fâ pons
indaûr. Al diaul, come incantesemât, al cjala ancjamò un pôc, ma dut in tun
al taca a sgavarî tanche lu vèssin scussiât. «Se âtu di ridi tant?», j
fâs Jàcun sensa scompònisi plui di tant. «Se ch’o ài di ridi?», j
rispuint al diaul. «Al è un pies che ti cjali. Îsal mût di cusî al to? A’
tu fasis glains cussì pìssulis che tu sês dome che tu impiris e tu dispiris.
Fintramài ’l àja’ di spietâ al paron di chê gjacheta li par screâla?».
Jàcun al cuntinua a fâ il so fat sen-sa nancja rispuìndigi, e alora ’l
diaul j fâs: «Ûtu scometi che jo ’o soi bon di cusî plui svelt di tè e di
finî un lavôr in tun svolet?». «Mah! Se pròpit tu ûs...», j rispuint cu
la sô pachea par gjavàsilu dai vôi. «Bon, ’a torni doman, alora! ’E
viodarin cui ch’al è plui svelt a fâ un pâr di barghessis!». Tal doman, a
buinora, ’l diaul al riva e la gara ’a scomensa. Par dî ’l vêr, al
sartôr al veva un bon fastidi, parvìa che dal diaul si podeva spietâsi di dut;
ma oramài nol era nuja di fâ, bisugnava cjapâla in dols e scomensâ. Ducjidoi
a’ sièlzin la roba e ’l model, a’ cjòlin i stamps, a’ tain li’
barghessis e pò... alo a cusî. Al sartôr, come simpri, al taja glains
curtutis e ’l scomensa a meti insieme i tocs. Al diaul, invèssit, al cjapa
’l rochel dal fîl, al scomensa a disrodolâlu e ’l fâs una glain tant
lungja che par tirâla, dopo vê dât al pont, al doveva traviarsâ dut al
plassâl e cori sù pal fassinâr che ’l era pojât tôr di una palada. Cu la
sô fiacuta ’l sartôr par misdì ’l veva finût al lavôr. Al diaul,
invèssit... al è ancjamò ch’al côr sù e jù pal fassinâr, vert di rabia
come un sborf. SARVIGNAN
Il diavolo e il sarto
153. Giacomo
era il sarto del paese e aveva sempre molto lavoro perché non aveva operai o
garzoni che lo aiutassero, perciò era costretto a fare tutto da solo: tagliare,
imbastire, cucire a spina, ribattere, fare il sopraggitto, stirare, misurare: in
una parola, faceva proprio tutto. Seduto sulla sedia, con un piede appoggiato al
traverso e l’altro su di una predella, curvo come un’arconcello sul lavoro,
cuciva svelto senza un attimo di tregua. Gli piaceva sedere accanto alla
finestra, un po’ perché ci vedeva meglio per la luce e un po’ perché di
tanto in tanto gettava un’occhiata fuori, sul piazzale, a chi passava di là.
Nella bella stagione teneva la finestra aperta affinché qualche conoscente
venisse a sedersi sul davanzale per scambiare quattro chiacchiere. A Giacomo
piaceva ascoltare le novità del paese e parlare di questo o di quello, ma,
mentre parlava o ascoltava, continuava ugualmente ad infilare o a togliere le
gugliate dall’ago per proseguire il lavoro. Un giorno d’estate, verso sera,
venne a sedersi sul davanzale della finestra nientemeno che il diavolo. Giacomo,
preso dal suo lavoro, non si turbò minimamente, e così il diavolo si mise ad
osservare attentamente, senza nemmeno respirare, come stava lavorando. Giacomo,
a dire il vero, aveva una gran fretta: doveva terminare una giacca per il giorno
seguente, perciò, senza mai sollevare la testa dal cucito, affondava svelto l’ago
nella stoffa e dava dei rapidi punti; poi, esaurita la gugliata, la tranciava
con i denti, toglieva il pezzetto rimasto, preparava un’altra gugliata, la
infilava nell’ago e ricuciva all’indietro. Il diavolo, affascinato, guardò
ancora un po’, poi, all’improvviso, si mise a ridere sguaiata-mente come se
qualcuno gli avesse fatto il solletico. «Che cos’hai da ridere tanto?», gli
chiese Giacomo con tutta calma. «Che cos’ho da ridere?», ribatté il
diavolo. «Da un pezzo ti sto osservando! Ma è codesto il modo di cucire? Fai
delle gugliate così corte che non fai altro che infilare e sfilare. Quanto
dovrà aspettare il proprietario di quella giacca per cominciare ad usarla?».
Giacomo continuò imperterrito il suo lavoro senza dare alcuna risposta, e
allora il diavolo propose: «Vuoi scommettere che io sono capace di cucire più
in fretta di te e di finire un lavoro in un batter d’occhio?». «Mah! Se
proprio vuoi...», gli rispose il sarto con la sua flemma, come per toglierselo
di torno. «Bene, torno domani allora! E vedremo chi dei due sarà il più
svelto nel cucire un paio di pantaloni!». Il giorno seguente, di buon’ora,
arrivò il diavolo e la gara ebbe inizio. A dire il vero, il sarto era piuttosto
preoccupato preoccupato perché dal diavolo ci si poteva aspettare qualsiasi
cosa, ma ormai non c’era più niente da fare: bisognava fare buon viso a
cattivo gioco ed incominciare. Scelsero entrambi la stoffa e il modello, presero
gli stampi, tagliarono i pantaloni e poi... sotto con l’ago! Il sarto, come
sempre, preparò delle gugliate piuttosto corte e iniziò a cucire i pezzi. Il
diavolo, invece, prese il rocchetto del filo, lo srotolò e fece una gugliata
così lunga che per tirarla, dopo avere dato il punto, dovette attraversare l’intero
piazzale e poi salire su di una fascinaia appoggiata ad un recinto. Con la sua
flemma, a mezzogiorno il sarto aveva terminato il lavoro. Il diavolo, invece...
sta ancora correndo su e giù per la fascinaia, verde di rabbia come un ramarro.
CERVIGNANO DEL FRIULI

El danât di
Viscon
157. E’
àn vût dit ch’al à vivût ca un omenat, trist che nissun sa, ch’al veve
fat tant dal mâl. Une volte ch’al ere sec e nol ploveve za di un pies, al è
lât fûr pa strade e ’l à tirâti al soreli, blestemant cuintri Diu. Un’altre
volte, parzeche ’a ere vignude le tampieste, a’ j à tirâti a un Crist in
crôs cu le sclope. ’A jè vignude le dì che ancje chist on, ch’al veve
tantis su le cussienze, al è muart. E’ àn fat el funerâl. E’ èrin pa
strade e e’ àn tacât a zirâ par àjar i corvas. Dut tun moment i ons ch’e
artàvin le casse no àn sintût plui nuje di grevi su li’ spalis, le casse no
pesave plui. «Siôr plevan», dissè un, «a’ nol è nuje chi drenti!». «Tasêt»,
dissè el predi, «e partait se che ’l è!». Cuanch’e son rivâs tal
simiteri e e’ àn mitude jù le casse, un sarpintat al è vignût fûr e ’l
si à intortolât ta casse. E dopo ancje ta piere da tombe ’a jè vignude fûr
le forme di un sarpint, e nissun al à rivât adore a parâle vie. CJOPRIS
Il dannato di Viscone
157. Dicevano che fosse vissuto qui un omaccio, cattivo oltre ogni dire,
che aveva fatto tanto male. Una volta, quando c’era la siccità e non pioveva
già da un pezzo, uscì in strada e sparò al sole, bestemmiando contro Dio. Un’altra
volta, poiché era venuta la grandine, sparò con il fucile a un Cristo in
croce. Venne il giorno in cui anche quest’uomo, che ne aveva tante sulla
coscienza, morì. Gli fecero il funerale e, mentre questo procedeva per la
strada del cimitero, incominciarono a volteggiare in aria dei corvi.
Improvvisamente gli uomini che portavano la bara non sentirono sulle spalle
alcun peso, la bara non pesava più. «Signor parroco», disse uno, «non c’è
niente qui dentro!». «Tacete», rispose il prete, «e portate quello che c’è!».
Arrivati al cimitero e deposta la bara, sbucò un serpentaccio che si
attorcigliò attorno alla bara. E in seguito anche sulla pietra tombale uscì la
forma di un serpente, e nessuno è mai riuscito a cancellarla. CHIOPRIS

Le contesse ’save
159. Le
contesse Locatele ’e ere une grande siore, triste come mai, e ’e tratave
mâl cu le int, cui colònos, no j lassave nuje. Fin che une dì ancje a jê j
à tocjâdi di murî. Dopo un pôc di timp, i fameis j dàvin saldo di mangjâ
ai pursìs, ma e’ vedèvin che un pursit nol meteve dongje nuje. E’ àn tant
scrupulât fintremài ch’e àn vidût che, cuanch’e ere ore di mangjâ, ’e
vignive tal laip une ’save e e’ mangjave sù dut. Nol restave nuje pal
pursit. Le Locatele dopo muarte ’e ere danade e ’e tornave ca in forme di
’save; ’e faseve dan... ancje dopo! CJOPRIS
La contessa rospo
159. La contessa Locatelli era una grande signora, cattiva come non mai,
trattava male la gente, i fittavoli, non gli lasciava niente. Finché un giorno
anche lei dovette morire. Dopo un po’ di tempo, i famigli continuavano a dar
da mangiare ai maiali, ma si accorsero che un maiale non non ingrassava affatto.
Si insospettirono parecchio finché videro che, all’ora del pasto, entrava nel
truogolo un rospo e divorava tutto. Al maiale non rimaneva nulla. La Locatelli
era una dannata e ritornava in questo mondo in forma di rospo. Faceva danno...
anche dopo morta! CHIOPRIS

El morôs
danât
162. Un
zòvin al ere lât militâr. E ’l à scrit sul prinzipi a le morôse, ma dopo
nol veve plui scrit. Jê ’e ere simpri a cjase ch’e filave. Une sere al ere
un grant lusôr di lune, e dut tun moment si viars le puarte e ’l ven drenti
el morôs: «Bune sere!». «Oh, bune sere! ’E jè ore che tu si fasis viodi:
mai scrit, mai nuje!». «Eh, sâtu... no ài vût timp. Ben, cumò ch’o soi
chi, nine, anin a fâ une cjaminade». «Anin», ’sè jê. E e’ van. «Se
inglassât che tu sês!», dissè jê, «Tu sês dut frêt!». «Eh, no sta’
migo crodi; sâtu, tal frêt, di gnôt...». Cuanch’e èrin un biel toc
indenant, le fantate ’e à diti: «Ma tu âs li’ mans propi induridis». «’O
ài fat tante strade ta chel frêt...». Dopo un pôc lui al dîs: «Clâr di
lune, el muart al cjamine. Ninete, âtu paùre?». «Pò no, ’o soi cun
tè!». Le fantate ’e scomenzave a vê un pôcje di paùre e si tirave indaûr.
Cjamine cjamine, chist zòvin le à menade viars el simiteri. Cuanche ’l è un
toc indevant, ’l à diti: «Âtu di lâ a cjase?». «Eh, no... cussì,
bessole». «Ma cun mè no tu podis vignî». Sichè jê lu cjape e lu strenz
par saludâlu: lui ’l ere dut inglassât. ’Tant che jê si à voltât un
moment, lui ’l è sparît. Alore le fantate si à voltât viars el simiteri e
’e à viodude dute une sflameade di fûc. El morôs al ere dut tune flame,
parseche ’l ere un danât. Le pùare morôse ’a jè lade a cjase, e dopo j
àn colâti duc’ i cjavêi da paùre. SAN VÎT
Il fidanzato dannato
162. Un giovane era andato a fare il militare. All’inizio aveva scritto
alla fidanzata, ma poi non l’aveva più fatto. Lei era sempre in casa a
preoccuparsi. Una sera c’era un grande chiaro di luna, e ad un tratto si
spalancò la porta ed entrò il fidanzato: «Buona sera!». «Oh, buonasera! È
ora che tu ti faccia vedere: mai scritto, mai nulla!». «Beh, sai... non ne ho
avuto il tempo. Ma ora che sono qui, cara, andiamo a fare una passeggiata?».
«Andiamo», rispose. E andarono. «Come sei gelido!», disse lei, «Sei tutto
freddo!». «Beh, non badarci: sai, nel freddo, di notte...». Dopo aver
camminato per un po’, la ragazza osservò: «Ma hai proprio le mani
induri-te». «Ho percorso tanta strada al freddo...». Dopo un altro po’, lui
disse: «Chiaro di luna, il morto cammina. Cara, hai paura?». «Ma no, sono con
te!».La ragazza pero incominciava ad aver timore, e cercava di tirarsi
indietro. Cammina e cammina, il giovane la tava conducendo verso il cimitero. Ad
un certo punto le disse: «Vuoi tornare a casa?». «Beh, no, così da
sola...». «Ma non puoi venire con me». Cosicché lei lo abbracciò e lo
strinse per salutarlo: lui era di ghiaccio. E mentre lei si era girata un
attimo, lui sparì. Allora la ragazza si è voltò verso il cimitero e vide una
gran fuoco. Il fidanzato era diventato una fiamma, perché era un dannato. La
povera giovane tornò a casa e in seguito, per la paura, le caddero tutti i
capelli. SAN VITO AL TORRE

Le gnot dai
Sanz a Porpêt
177. Jo
’o sai che chi, a Porpêt, e jo mi ricuardi ben, si usave meti fôr dal
puarton une forcjade di starfòi o di arbe mèdiche o di fen, e un seglot di
aghe pal mus, un âtri seglot di aghe nete pa Madone, i agnui e duc’ i sanz.
In ta chê gnot, in pruzzission, e’ vignìvin a bevi in tal seglot e j dàvin
di bevi ancje al mus. Chist preparatîf al doveve jessi fat prime di miezegnot,
parzeche dopo miezegnot no bisugnave fâ nuje, e guai a lâ fôr di cjase: si
coreve el riscjo di jodi i spirz. PORPÊT
La notte d’Ognissanti a Porpetto
177. So che qui, a Porpetto, e lo ricordo bene, si usava disporre fuori
del portone una forcata di trifoglio o di erba medica o di fieno, e un secchio d’acqua
per l’asino, un altro secchio d’acqua pulita per la Madonna, gli angeli e
tutti i santi. In quella notte, in processione, venivano a bere nel secchio e
davano da bere anche all’asino. Questi preparativi dovevano essere fatti prima
della mezzanotte, perché dopo mezzanotte non bisognava fare niente; e guai ad
uscire di casa: si rischiava di vedere gli spiriti. PORPETTO

La gnot dai
Muars tal Lûc Brusât
189. Cuanch’a
sunava la campana da l’Ave Marìa, ogni fruta par ben ’a doveva tornâ a
cjasa; cjatâsi in ’sîr di gnot al podeva essi pericolôs. A l’ora di gnot
la cjampana granda ’a visava che bisugnava dî un De profundis pai muars,
distudâ la lum e lâ tal jet. Tal Lûc Brusât, in tuna famea di colònos, una
fruta che si calmava Ùrsula, cuanche in cjasa duc’ a’ èrin a durmî, ’a
à vût bisugna di lâ... dulà che nissun podeva lâ par jê. E ’a era la
gnot dai Muars! Chel puest al era vissin dal le-danâr: al tocjava passâ dut al
bears. ’L era clâr di luna ma chel lusôr gi meteva ancjamò plui paùra, al
fassinâr al sameava una granda cjasa scura, e la fruta ’a saveva che propi li
tal mies ’a era come una tana e ’a veva paùra che salti fûr cualchidun.
Par dâsi coragjo ’a pensava: «E pûr di dì ’a voi drenti a platâmi
cuanch’e ’suin di cucuc!». Ormài si veva abituada al lusôr di luna e, fat
se ch’a veva di fâ, ’a taca a cori a cjasa ma, cuanche ’a riva tal stret
dal fassinâr, un bocognon di gjat si met tal mies da stradela e daûr di lui
’a salta fûr una vecja. Al cûr ’l pareva che gi scjampi: tun... tun... tun...
La vecja ’a rideva tal viòdila tant spaurida e gi dîs: «Ùrsula, Ùrsula!
Ven cun mè che ti parti in paradîs!». Ma Ùrsula ’a coreva cui pîs in tal
cûl e ’a veva un biel sefâ a parâsi dal gjat, che la sgrassava par duti’
li’ bandis, e par no piardi al libri di scuela. Al era l’ùnic libri ch’a
veva: gi lu veva regalâti la fia dal cont, e lu partava simpri cun sè par
paùra che i fradis gi lu ròmpin. Al gjatat al sgnaolava rabiôs parseche nol
rivava a fermâla. A farsa di vitis, cul vistît dut sbregât e li’ gjambi’
sgrassadis, ’a riva in cjasa, ma ’l gjat, svelt, al met al cjâf ta sfresa
da puarta. Ùrsula ’a sburtava par siarâ cu la clâf, ma no rivava: la vecja
’a oreva cjôigi al libri cun tuna man, e cun chê âtra gi tirava i cjavêi,
e simpri plui fuart ’a sberlava: «Ven cun mè! Ven cun mè, che ti parti in
paradîs!». La pura fruta no podeva plui: s’a clamava sô mari li’ vares
sintudis, parsech’a doveva jevâ a bunora par lâ tal cjamp; e cussì si à
rassegnât a tirâ al libri tal bears. ’L è bastât chel moment che si àn
’sirât, e jê ’a ’nd’à pudût siarâ cu la clâf. Al cûr al bateva
simpri plui, ma ormài ’a era sul sigûr. La vecja no si rassegnava di vêla
piarduda e ’a pestava la puarta, e intant al gjat al sgnaolava che ’l pareva
un frut ta scuna. Prin di lâ disora, Ùrsula ’a va a cjalâ pal barcon dal
fogolâr s’a èrin lâs via. Ma, ’pena tirada in banda la tindina, ’a
viôt un siet di lôr ch’a fasèvin un bal in sercli, e duc’ a’ sberlàvin:
«Ven cun nôoo... Ven cun nôoo... Ven cun nôoo...!». Al lusôr di luna gi à
lassâti viodi in musa chê’ personis: a’ èrin duc’ muars, e fra chei ’a
era la vecja ch’a oreva cjapâ-la... ma chê ’a era viva! ’A vigniva ogni
vìnars di Grau a vendi al pes. Si clamava Milia ’Sefa e ’a passava cu la
cassela sul cjâf sberlant: «Pesse, done!». Lada tal jet, Ùrsula no rivava a
cjapâ sun, e intant ’a pensava: «Ma àjo di vê fat un brut sun?». Tal
doman ’a ’nd’à cjatât al libri tal bears dut rot, e ancja al so vistît
’l era sbregât, e jê ’a era sgrassada par duti’ li’ bandis. ’A
spietava al vìnars par viodi la Milia ’Sefa, ma la gradisana no jè plui
vignuda tal Lûc Brusât: a’ àn sintût ta ostarìa ch’a era muarta al dì
dai Sans! Sol un bocon di gjat al ’sirava, grant plui di duc’ i gjas di
Scodovacja e di Vila. Ùrsula, a viodi chel gjat, s’inglassava di paùra. «Ghes!
Ghes!», gi sberlava; gi tirava clas, ma lui la cjalava fis tai vôi, sensa lâ
via... SCODOVACJA
La notte dei Defunti nel Luogo Bruciato
189. Quando suonava la campana dell’Avemaria, ogni ragazza per bene
doveva tornare a casa; trovarsi fuori al buio poteva essere pericoloso. Al calar
della notte la campana maggiore avvertiva che bisognava recitare il De profundis
per i morti, spegnere il lume ed andare a letto. Nel Luogo Bruciato, in una
famiglia di fittavoli, una ragazzetta di nome Orsola, mentre in casa tutti
dormivano sentì la necessità di andare... dove nessun’altro poteva andare al
posto suo. Ed era la notte dei Defunti! Quel sito si trovava accanto alla
concimaia: bisognava attraversare tutto il cortile. C’era chiaro di luna ma
quella luce le incuteva ancor più paura, la fascinaia sembrava una grande casa
buia e la bambina sapeva che là in mezzo c’era una specie di tana e temeva
che ne uscisse qualcuno. Per farsi coraggio pensava: «Eppure di giorno vado a
nascondermici quando giochiamo a rimpiattino!». Si era ormai abituata al
chiarore della luna e, fatto quello che doveva fare, si mise a correre verso
casa ma, arrivata alla strettoia della fascinaia, un grosso gatto si piazzò in
mezzo al viottolo e dietro di esso comparve una vecchia. Le parve che il cuore
le scoppiasse: bum... bum... bum.... La vecchia rideva vedendola così
spaventata e le disse: «Orsola, Orsola! Vieni con me ché ti porto in
paradiso!». Ma Orsola corse con le gambe in spalla, ed aveva il suo bel daffare
a difendersi dal gatto che la graffiava dappertutto e a non perdere il libro di
scuola. Era l’unico libro che possedeva: gliel’aveva regalato la figlia del
conte e lo portava sempre con sé per timore che i fratelli glielo rompessero.
Il gattaccio miagolava rabbioso perché non riusciva a fermarla. Dopo molti
sforzi, con il vestito strappato e le gambe graffiate arrivò in casa, ma il
gatto infilò lestamente la testa fra i battenti della porta. Orsola spingeva
per riuscire a chiudere a chiave ma non ce la faceva. La vecchia voleva
prenderle il libro con una mano e con l’altra le tirava i capelli, mentre
strillava sempre più forte: «Vieni con me! Vieni con me ché ti porto in
paradiso!». La povera bambina non ne poteva più: se avesse chiamato in aiuto
la madre, sarebbe stata rimproverata, perché doveva alzarsi presto per andare
al lavoro nei campi; perciò si rassegnò e lanciò il libro nel cortile. Fu
sufficiente l’istante in cui si volsero, per riuscire a chiudere a chiave. Il
cuore le batteva sempre più forte, ma ormai era al sicuro. La vecchia però non
si dava pace per averla perduta e continuava a battere alla porta, mentre il
gatto miagolava tanto che sembrava un bambino nella culla. Prima di salire in
camera, Orsola andò a guardare dalla finestrella del focolare per vedere se se
ne fossero andati. Ma, appena ebbe scostato la ten-dina, vide sette persone che
ballavano in cerchio e gridavano: «Vieni con noiii... Vieni con noiii... Vieni
con noiii...!». Il chiarore della luna le permise di vederli in faccia: erano
tutti morti e fra essi c’era la vecchia che voleva prenderla. Ma quella era
viva! Veniva ogni venerdì da Grado a vendere il pesce. Si chiamava Emilia
Giuseppa e passava con la cassetta sulla testa gridando: «Pesse, done!».
Andata a letto, Orsola non riusciva a prendere sonno, e intanto pensava: «Ma,
non avrò fatto un brutto sogno?». Il giorno seguente trovò nel cortile il
libro tutto rotto, ed anche il suo vestito era stracciato e lei era coperta di
graffi. Attese il venerdì per incontrare Emilia Giuseppa, ma la gradese non
venne più nel Luogo Bruciato; avevano sentito dire all’osteria che era morta
il giorno d’Ognissanti! Si aggirava soltanto un grosso gatto, più grande di
tutti i gatti di Scodovacca e di Villa Vicentina. Orsola, vedendolo, si
raggelava per la paura. «Sciò! Sciò!», gli gridava; gli tirava dei sassi, ma
lui la fissava negli occhi, senza andarsene... SCODOVACCA

Al fantat e ’l
vues
208. Una
sera un fantat al tornava a cjasa di morosâ. Biel fasint la strada, al à
cjatât un vues. Lui nol à pensât che ’l pol essi di un cristian e gi à
dâti una pidada. «Cjo’!», dissè, «Tu vegnarâs a la me gnossa co mi
spo-sarài!». Al ven al dì che ’l si sposa e a’ èrin duc’ biel ’sa
prons in taula par mangjâ, e a’ sìntin a bati la puarta. E ’a dîs la
parona di cjasa: «Va’ a viarsi. Sacôr al sarà un pûr a sirî la caretât».
A’ van a viarsi la puarta e si presenta un biel ’sòvin, che nissun lu
cognosseva, e al domanda dai nuvìs. Ma ’l nuvìs si à maraveât e ’l dîs
di no cognòssilu par nuja. «Eh no!», dissè al forest, «A’ tu mi âs
invidât a gnossis!», e sensa dî ni trê ni cuatri al ven in cjasa e ’l si
sinta tal mies da clapa in taula. Al nuvìs al è restât sensa peraulis. La int
’a à mangjât e fat fiesta, ma chel ’sòvin forest al stava simpri par so
cont, sidin. Dopo cualchi ora, al va dongja dal nuvìs e gi dîs: «Jo devi lâ
via. Vêtu a compagnâmi un toc ch’e ài di contâti una roba?». Alora il
nuvìs, content di gjavâssilu dai pîs, al va a compagnâlu. E ’nd’àn fat
simpri chê strada che ’l veva fat al nuvìs un an prima, co gi veva dâti la
pidada a di chel vues. Dut tun moment al forest, che ’l era stât saldo sidin,
al dîs: «Cumò tu podis lâ a cjasa. Grassiis di vêmi compagnât e mandi!».
Alora al nuvìs, che nol saveva plui se pensâ di chê’ vinturis che gi
tocjàvin, al è tornât indaûr. Ma nol cjatava plui i sô’ lûcs e nol
cognosseva plui i puesc’ li atôr. Alora gi à domandâti a un che ’l
passava pa strada, e gi à contâti alc da sô storia: che ’l era stât via
una oruta e cumò nol rivava a cjatâ nancja la sô cjasa: robis di doventâ
mas. «Benedet», dissè chel âtri,» «jo no ài sintût nancja nomenâ chê
int e chei lûcs che tu disis!». Al nuvìs, avilît, al va a domandâigi al
plevan dal paîs, che ’l è lât a viodi tai libris dai muars. E li al saltava
fûr che al nuvìs e la sô int a’ èrin vivûs trisinta ains prima. Lui gi
veva dâti una pidada a un vues e al muart al era vignût e lu veva partât tal
so mont domo un’oruta. Ma ca di nô a’ èrin tristinta ains! E alora chel
nuvìs al è vignût di colp vecjonon e ’l è muart. FLUMISEL
Il giovane e l’osso
208. Una sera un giovanotto rincasava dopo essere stato dalla fidanzata.
Mentre percorreva la strada, trovò un osso. Non pensò che avrebbe potuto
essere di un cristiano e gli diede un calcio. «To’!», disse, «Verrai alle
mie nozze quando mi sposerò!». Venne il giorno del matrimonio e tutti erano
già pronti a tavola per mangiare, quando sentirono bussare alla porta. Disse la
padrona di casa: «Vai ad aprire. Forse è un mendicante che cerca la carità».
Aprirono la porta e si presentò un bel giovane, che nessuno conosceva, e chiese
degli sposi. Ma lo sposo se ne stupì e disse di non conoscerlo affatto. «Eh
no!», ribatté il forestiero, «Mi hai invitato alle nozze!», e senza far
parola entrò in casa e si sedette a tavola in mezzo alla compagnia. Lo sposo
rimase di stucco. Gli invitati mangiarono e fecero festa, ma il giovane
forestiero se ne stette sempre zitto per proprio conto. Dopo qualche ora, si
avvicinò allo sposo e gli disse: «Io devo andare. Vieni ad accompagnarmi per
un tratto, ché devo raccontarti una cosa?». Lo sposo allora, felice di
levarselo dai piedi, lo accompagnò. Percorsero di nuovo la stessa strada fatta
dallo sposo un anno prima, quando aveva dato un calcio all’osso. Ad un certo
punto il forestiero, che era rimasto sempre in silenzio, disse: «Ora puoi
tornare a casa. Grazie per avermi accompagnato e arrivederci!». Lo sposo, che
non sapeva più che cosa pensare delle stranezze capitategli, tornò indietro.
Ma non vedeva più i suoi luoghi e non riconosceva nemmeno i dintorni. Fermò
allora un passante e gli raccontò in parte la sua storia: che si era assentato
un’oretta e che ora non riusciva neanche a ritrovare la propria casa: cose da
far ammattire. «Figliolo», rispose l’altro, «io non ho nemmeno sentito
nominare la gente e i luoghi che dici!». Lo sposo, avvilito, andò a chiedere
aiuto al parroco del paese, che consultò il registro dei defunti. E lì si
scoprì che lo sposo e la sua famiglia erano vissuti trecento anni prima. Egli
aveva dato un calcio a un osso e il morto era venuto e l’aveva portato nel suo
mondo soltanto per un’oretta. Ma qui da noi erano passati trecento anni! Lo
sposo diventò di colpo vecchissimo e morì. FIUMICELLO

Caìn ta lune
223. ’A
savarês ben che Caìn al à copât so fradi cun tun len. Alore Diu lu à
cjastiât e lu à parât su la lune, là che ’l devi partâ une fassine di
chei lens che j àn coventâti une volte par copâ. E cuanche si ere frus, i
vècjos nus mostràvin la lune cun chê’ maglis scuris ch’e ’nd’à. E’
disèvin: «Viodêso chê magle là, propi tal mies? Chel al è Caìn, dut plet,
ch’al parte la fassine. No stait a fâ i trisc’, se no ’a larês une dì
ancje vuâtris là sù!». CJOPRIS
Caino sulla luna
223. Sapete bene che Caino uccise il fratello con un bastone. Dio,
allora, lo punì e lo mandò sulla luna, dove deve portare un fascio della legna
che gli era servita per uccidere. Quando eravamo bambini, i vecchi ci mostravano
la luna e, additando quelle macchie scure, dicevano: «Vedete quella macchia,
proprio nel mezzo? Quello è Caino, tutto curvo, che porta il fascio. Non fate i
cattivi, altrimenti un giorno andrete anche voi lassù!». CHIOPRIS

I bûs ta gnot
di Nedâl
228. La
gnot di Nedâl li’ bestiis a’nd’àn al podê di fevelâ e a’ san ancja
chel ch’al sussedarà. Ma no bisognava vê massa curiosetâs ta chisti’
robis. Alora i vècjos a’ contàvin che una volta a’ stàvin culì dongja
doi fradis ch’a vèvin una biela stala di nemâi. Una gnot di Nedâl un dai
doi fradis, Meni, gi à diti a chel âtri: «Cjo’, Jàcun! Anin, anin ta stala,
ch’e fasin cjacarâ i nemâi! ’A soi saneôs di sintî se ch’a dìsin».
Alora a’ van ducjidòi ta stala, e Meni, su la puarta, cjalant i doi bûs ch’a
vèvin, a’ gi dis: Bo da fûr, bo da man, se fasarino mai doman? Dopo un prin
moment di sidin, un dai doi bûs a’ si ’nd’à voltât cul cjâf viars la
puarta e ’l à dit: «Doman ’a larin a cjoli li’ breis par fâgi la cassa
al paron!». Podêso domo imagjinâsi al spacon che ’l à cjapât Meni? Al è
saltât fûr da stala come mat, al si à insopedât in tuna piera e ’l si à
copât: propia cussì como che ’l veva strolegât al bo! ÌSULA
I buoi nella notte di Natale
228. La notte di Natale le bestie hanno il potere di parlare e conoscono
anche ciò che succederà. Ma non bisogna essere troppo curiosi in queste cose.
Raccontavano i vecchi che un tempo abitavano qui vicino due fratelli che
possedevano una stalla ben fornita di animali. In una notte di Natale uno dei
due, Domenico, disse al fratello: «Ehi, Giacomo! Andiamo, andiamo nella stalla,
ché facciamo parlare gli animali! Sono ansioso di sapere che cosa dicono».
Andarono quindi entrambi nella stalla, e Domenico, dalla porta, guardando i due
buoi che avevano, disse loro: Bue di sinistra, bue di destra, che cosa mai
faremo domani? Dopo un attimo di silenzio, uno dei due buoi volse la testa verso
la porta e rispose: «Domani andremo a prendere le tavole per fare la bara al
padrone!». Potete soltanto immaginare lo spavento che si prese Domenico! Balzò
fuori dalla stalla come un matto, inciampò in una pietra e rimase ucciso:
proprio come aveva pronosticato il bue. ISOLA MOROSINI

La Madona e li’
dô’ striis
229. Cuanche
la Madona e san Jusef a’ son lâs par dovê a Jerusalem, Jesù ’l à lâti
via sensa visâju e ’l è lât a cjacarâ cui studiâs ebrèos. Alora la
Madona e san Jusef a’ àn pesseât a lâ a sirîlu. Pa strada a’ àn vidût
ta un cjamp trê brâs seadôrs. «O boins seadôrs, vêso vidût me fi?».
«Nô no lu vin vidût e tant màncul cognossût!». Lant indenant, a’ àn
vidût sun tuna roja trê lavandaris ch’a lavàvin la blancjarìa. «O buni’
fèminis, vêso vidût me fi?». «Nô no lu vin vidût e tant màncul
cognossût!». La Madona ’a va indenant vaìnt e suspirant. E ’a cjata dô’
striis ch’a vignìvin da sitât. «O buni’ fèminis, vêso vidût me fi?».
«Lu vin cognossût, ma di chi nol è passât. Tornait in sitât, là lu
cjatarês». La Madona lis à binididis e lis à ringrassiadis, e ’a à diti:
«Par ringrassiament nissun vi palesarà vuâtris dôs, cuanch’a larês pal
mont tal vuestri mistîr». FLUMISEL
La Madonna e le due streghe
229. La Madonna e san Giuseppe andarono per necessità a Gerusalemme e
Gesù si allontanò senza avvertirli ed andò a parlare con i sapienti ebrei.
Allora la Madonna e san Giuseppe si misero subito a cercarlo. Lungo la strada,
videro in un campo tre falciatori: «O buoni falciatori, avete visto mio
figlio?». «No, non l’abbiamo visto e tanto meno conosciuto!». Proseguendo,
videro accanto ad una roggia tre lavandaie che lavavano i panni. «O buone
donne, avete visto mio figlio?». «No, non l’abbiamo visto e tanto meno
conosciuto!». La Madonna procedette piangendo e sospirando. E incontrò due
streghe che venivano dalla città. «O buone donne, avete visto mio figlio?».
«Lo abbiamo conosciuto, ma da qui non è passato. Tornate in città, là lo
troverete». La Madonna le benedisse e le ringraziò, poi disse: «Come
ringraziamento, nessuno vi scoprirà, quando andrete per il mondo a esercitare
il vostro mestiere». FIUMICELLO

I doi cul
falsot
241. Al
Signôr e san Pieri a’ làvin in zîr pal Friûl. Una dì a’ viòdin un che
’l era a seâ su la riva di una fuessa. Al veva pojât al falsot ta un
vencjâr e invessi di seâ al stava fêr cjalant al sîl e ’l preava sot vôs;
’a era duta la riva ’cjamò di fâ e ’l soreli al era za alt. I doi a’
si àn fermât e a’ varèssin vût di domandâgi alc, ma ’l Signôr gi à
diti a san Pieri: «No sta’ a bassilâ cun chel li, Pieri. Dagi un sburt e
bùtilu ta fuessa!». Pieri al è restât a sintîsi dî cussì, ma pal rispiet
che ’l veva pal Signôr al à fat como che ’l veva sintût. Podopo a’ van
indenant pa strada e a’ rìvin, simpri sul ôr di una aga, là che un âtri on
al stava seant li’ siestis. Gi van dongja par domandâgi alc e chel là gi
sberla di rabuf: «Vait via di ca! ’A no ’nd’ài timp di piardi jo cun duc’
chei ch’a van a torzeon! Vait dilunc, sacra-bolt!». Alore Pieri al scomensava
a tontonâ, ma ’l Signôr, che ’l pareva scuasi content, al à dit: «Pieri,
sta’ bon. Va’ invessi a udâlu e dagi ancja un carantan a di chel li».
Alora Pieri nol podeva plui tignî-si e ’l si ’nd’à sbrocât: «Ma semût?
’A stimi vô, Signôr! Mi vês fat butâ ta fuessa chel là via che ’l
preava e cumò mi disês di udâ chel stupidat di on culì, che nus manda via
cun peraulatis!». «Scolta, Pieri. Se duc’ a’ fòssin compagn dal prin, tu
varessis di viodi! La tiara, par ch’a dedi di mangjâ, tu âs di lavorâla.
Furtuna ch’a son tainc’ di chei compagn di chel che ’l si veva inrabiât
cun nô!». FLUMISEL
I due falciatori
241. Il Signore e san Pietro andavano in giro per il Friuli. Un giorno
incontrarono un tale che stava falciando la riva di un fossato. Aveva appoggiato
la falce ad un salice e, invece di falciare, stava immobile con gli occhi al
cielo e pregava sottovoce. Lo sfalcio non era ancora stato fatto e il sole era
già alto. I due si fermarono e avrebbero voluto chiedergli l’elemosina, ma il
Signore disse a san Pietro: «Non darti pensiero di quello lì, Pietro. Dagli
una spinta e gettalo nel fosso!». Pietro rimasto di stucco nel sentirsi dire
ciò ma, per il rispetto che aveva per il Signore, fece come gli era stato
ordinato. Proseguendo il loro cammino, giunsero, sempre sul bordo di un corso d’acqua,
dove un’altro uomo stava falciando i margini. Gli si avvicinarono per
chiedergli la carità ed egli gridò loro con rimprovero: «Via di qua! Io non
ho tempo da perdere con i vagabondi! Andatevene, accidenti!». Pietro prese a
brontolare ma il Signore, che sembrava quasi contento, gli disse: «Sta’
buono, Pietro. Vai piuttosto ad aiutarlo e dagli anche una moneta». Pietro
allora non riuscì più trattenersi ed esplose: «Ma come? Mi meraviglio di voi,
Signore! Mi avete fatto gettare nel fosso quello là che stava pregando, e ora
mi dite di aiutare questo villanzone, che ci ha mandati via con male parole!».
«Ascolta, Pietro. Se tutti fossero come il primo, poveri noi! La terra, perché
produca cibo, bisogna lavorarla. Per fortuna ce ne sono tanti come quello che si
è arrabbiato con noi!». FIUMICELLO

La rassa
243. Al
Signôr e a san Pieri in tun lûc a’ gi vèvin regalâti una rassa. Al Signôr
al dîs: «Ben pò, Pieri, bisogna fâla cuei cumò e si la mangjin!». Alora
Pieri al à pensât a cueila, ma gi à vignûti una golona e ’l à mangjât
una sata. E cussì dopo a’nd’à partât in taula la rassa ben cueta ma cun
tuna sata sola. «Pieri, ’a vevia domo una sata chê rassa chi?». «Eh,
cussì pò! Jo no sai se dî: ’a veva domo una!». Alora al Signôr che ’l
oreva dâgila d’insegnâ a Pieri, tal doman, viodint un trop di rassis sul ôr
di una roja cu li’ talputis sù, li’ ’nd’à sfolmenadis: «Siò! Siò!».
«Viôtu, Pieri, che no è nissuna cun tuna sata sola?». «E parsè no gi vêso
fati cussì, siò! siò!, ancja a chê rassa ch’a era tal plat?». Al Signôr
a’ gi à tocjâti di ridi e par chê volta a’ gi la ’nd’à bonada a san
Pieri. FLUMISEL
L’anitra
243. In una località al Signore e a san Pietro avevano regalato un’anitra.
Il Signore disse: «Ebbene, Pietro, ora bisogna cuocerla e poi ce la
mangiamo!». Pietro provvide a cuocerla, ma gli venne una gran gola e ne mangiò
una zampa; perciò più tardi portò in tavola l’anitra ben cotta, ma con una
zampa sola. «Pietro, quest’anitra aveva soltanto una zampa?». «Mah, dev’essere
così! Io non so che cosa dire: ne aveva solo una!». Il Signore, che voleva
dare una lezione a Pietro, il giorno seguente, vedendo un gruppo di anatre sul
bordo di una roggia, con le zampe bene in vista, le disperse: «Sciò! Sciò!».
«Vedi, Pietro, che non ce n’è nessuna con una zampa sola?». «Allora
perché non avete fatto lo stesso, sciò! sciò!, anche a quella che stava nel
piatto?». Il Signore fu costretto a ridere e per quella volta gliela perdonò.
FIUMICELLO

Al Crist da’
Disgrassiis
252. Sun
tun mûr par dentri di una vecja cjasa di Acuilea, lûc da Confratèrnita dal
Rosari, al era un Crist in crôs, di len, picjât. Par sintût a dî dai vècjos
a’ no bisognava mai tocjâlu, mai tirâlu via di là che ’l era picjât. Cui
che lu veva tirât jù, una volta, al veva vût domo disgrassiis ta famea. Par
chel la int ’a lu cognossèvin come ’l Crist da’ Disgrassiis. [Il Crist
cumò al si cjata in tuna glesia a Gurizza]. ACUILEA
Il Crocifisso delle Disgrazie
252. Su di una parete interna di una vecchia casa di Aquileia,
appartenuta alla Confraternita del Rosario, era appeso un Crocifisso di legno.
Ho inteso dire dai vecchi che non si doveva mai toccarlo, mai toglierlo da dov’era
appeso. Una volta, chi aveva osato toccarlo aveva avuto soltanto sciagure in
famiglia. Per questo motivo la gente lo conosceva come il Crocifisso delle
Disgrazie. [Il Crocifisso si trova attualmente in una chiesa di Gorizia].
AQUILEIA

I bisiacs fra
dôs aghis
275. A’
àn vût dit che una volta al Teritori (cussì a’ clamàvin i vècjos i paîs
di lâ dal Isuns) al era restât sensa int, no si sa parsè. Alora i venessians,
parons di chê tiara, a’ àn fat vignî âtra int di duti’ li’ bandis là
che ’l comandava al leon di San Marc. E chisc’ foresc’ a’ son stâs
clamâs bisiacs, parseche si vèvin stabilît in tuna tiara fra dôs aghis,
bisaquae. E gi à restâti ancjamò chel non al dì di vuê. Cualchidun al dîs
che i prins paîs bisiacs a’ sarèssin stâs Turià, Cassean, Bean e San Pieri.
CJAMPLUNC
I bisiachi tra due acque
275. Si diceva che il Territorio (così i nostri vecchi chiamavano le
località d’oltre Isonzo) fosse rimasto spopolato: non si sa il perché. I
veneziani, che dominavano quella terra, vi fecero arrivare gente proveniente da
tutti i luoghi dove comandava il leone di San Marco. Questi stranieri vennero
chiamati bisiachi, perché si erano stabiliti fra due corsi d’acqua, bis-aquoe.
E con tale nome sono designati ancor oggi. Qualcuno sostiene che i primi paesi
bisiachi sarebbero stati Turriaco, Cassegliano, Begliano e San Pier d’Isonzo.
CAMPOLONGO AL TORRE

Àtila a
Bielvedê
278. Dopo
che Àtila al veva concuistât Acuilea, al vares orût ancja còrigi daûr a la
int scjampada su li’ ìsulis di Grau, scrupulant ch’a vèssin una part da’
ricjessis. Ma, rivât a Bielvedê, al à viodût ch’a èrin i palûs e li’
marinis e che nol vares pudût lâ indenant cui cjavài. Alora al à fat copâ
una sdruma di int di chei prisunîrs che ’l veva, par butâju ta l’aga un
parsora di chel âtri, e cussì lui, Àtila, e la sô armada a’ gi varèssin
passâti parsora a cjaval. Nol à rivât nancja cussì, e ’lora lu àn vidût
che ’l cjalava banda Grau rabiôs e ’l diseva chisti’ peraulis: «Achì
par mè al è domo un biel vedê!». E ’l à voltât al cjaval e ’l è lât
via blestemant compagn dal diau. Dopo di chê volta al puest a’ si ’nd’à
clamât Bielvedê. BIELVEDÊ
Attila a Belvedere
278. Dopo che Attila ebbe conquistato Aquileia, volle pure inseguirne gli
abitanti fuggiti sulle isole di Grado, sospettando che avessero con sé una
parte delle loro ricchezze. Ma, giunto a Belvedere, vide che tutt’intorno c’erano
solo paludi e laguna e che non avrebbe potuto procedere con i cavalli. Allora
fece uccidere un mucchio di prigionieri che aveva catturato e li fece gettare
nell’acqua uno sull’altro, così che lui e la sua armata vi sarebbero
passati sopra a cavallo. Non riuscì nemmeno in questo modo. Lo videro perciò
guardare rabbioso verso Grado e pronunciare queste parole: «Qui per me non c’è
altro che un bel vedere!». Voltò il cavallo e se ne andò bestemmiando come il
diavolo. Da allora il luogo fu chiamato Belvedere. BELVEDERE

Àtile soterât
in tun flunc
287. Me
pari al contave simpri le storie da muart di Àtile, che le veve sintude di so
pari e cussì vie. Al diseve che Àtile al è muart dongje Nacuilee e, par
soterâlu, al è stât disviât un flunc. In tal flunc i sie soldâz e’ àn
scavadis trê busis. In ta prime buse e’ àn mitude jù une casse, fate dute
di aur, cun drenti il cuarp di Àtile. In ta seconde buse e’ àn mitude jù un’âtre
casse, dute d’arint, cun drenti i sie bêz e il so tesaur. In ta tiarze buse e’
àn mitude jù un’ùltime casse, fate di fiâr, cun drenti li’ sie armis.
SAN ZORZ
Attila sepolto in un fiume
287. Mio padre ripeteva spesso la leggenda della morte di Attila, che
aveva sentito da suo padre e così via. Diceva che Attila era morto nelle
vicinanze di Aquileia e che, per seppellirlo, era stato deviato un fiume. In
esso i suoi soldati scavarono tre fosse. Nella prima deposero una bara, tutta d’oro,
con dentro il suo cadavere. Nella seconda fossa calarono un’altra bara, tutta
d’argento, con dentro il suo denaro e il suo tesoro. Nella terza misero un’ultima
cassa, di ferro, con dentro le sue armi. SAN GIORGIO DI NOGARO

Il frutin e le
magne
310. E’
contàvin che une volte a un frut pìzzul j ere muarte le mari e ’l ere
restât bessôl. Dopo un ziart timp che si son ’nacuarz, e’ son lâz par
cjoilu; no sôl nol vaìve da fan, ma lu àn cjatât ch’al rideve. Chisc’ si
son maraveâz e e’ pensàvin ch’e fos sô mari a fâlu ridi. In vezzi ’e
ere li une magne, e chê ’a j rigurgjitave in bocje al frut il lat apene
tetât di une vacje. ZILINE
Il bambino e la biscia
310. Raccontavano che una volta a un bambino piccolo era morta la madre
ed era rimasto solo. Dopo un certo tempo se ne accorsero ed andarono a
prenderlo, ma, anziché piangere per la fame, videro che rideva.Con meraviglia
pensarono addirittura che fosse la madre a farlo ridere. Invece c’era una
biscia che rigurgitava in bocca al bambino il latte appena succhiato da una
mucca. ZELLINA
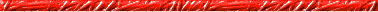

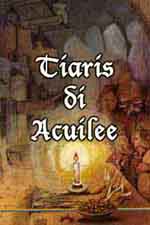
 Une
volte si jodèvin da’ rubis... Jo ’o eri frute e ’o vevi fan: alore ’o soi lade
cjase a domandâj a mê mâri alc di mangjâ. «No ài nuje», ’sè mê mâri, «Va’ in
tal cjamp a mangjâ ue». E cussì ’o soi lade in ta chel cjamp tacât da ferade,
dongje dai cjasâi di Pantanali. Conch’o soi tal cjamp ch’o mangji ue, ’o sint
une sivilade. «E’ crodaran ch’o sedi a robâ ue», ’o ài pensât, «Ma... intant
jo ’o soi tal me!». ’O sint altris dôs siviladis. «Ma ze âno i Pantanâi?», ’o
disevi tra di mè, «Ma no jòdino che no cjôl le ue in tal so?». Le tiarze sivilade...
’O voi daûr di là ch’e àn sivilât. In tal prât di Dell’Olio al è un morâr, e
’o jôt une fèmine sintade su chist morâr che si ten sù sun dun branc. Chiste
fèmine ’e ere dute vistude a neri, cu li’ gjambis a pendolon e cui pîs luncs
e a spiz... ancje chei neris. Chiste fèmine mi cjalave e mi cucave, di ca e
di là dal branc, fasint dondolâ li’ gjambis. Mi soi fermade a cjalâ par un biel
toc chê fèmine dute nere. Mi veve sivilât par che le cjali e cumò no mi diseve
nuje... Chê fèmine grande e dute nere, ch’e jere di sigûr une fade, ’e cuntinuave
a cjalâmi dondolant chê’ gjambis cui pîs a spiz e fasint cucuc di ca e di là
dal ramaz. Jo no ài cjapade paùre e, dopo un toc che le cjalavi, judût che chê
fèmine no mi diseve nuje, ’o ài saltade le fuissute e mi soi inviade viars cjase.
Conch’o soi un biel toc indevant, pensant a chê strane figure, mi soi dizzidude
di tornâ a jòdile. SAN ZORZ
Une
volte si jodèvin da’ rubis... Jo ’o eri frute e ’o vevi fan: alore ’o soi lade
cjase a domandâj a mê mâri alc di mangjâ. «No ài nuje», ’sè mê mâri, «Va’ in
tal cjamp a mangjâ ue». E cussì ’o soi lade in ta chel cjamp tacât da ferade,
dongje dai cjasâi di Pantanali. Conch’o soi tal cjamp ch’o mangji ue, ’o sint
une sivilade. «E’ crodaran ch’o sedi a robâ ue», ’o ài pensât, «Ma... intant
jo ’o soi tal me!». ’O sint altris dôs siviladis. «Ma ze âno i Pantanâi?», ’o
disevi tra di mè, «Ma no jòdino che no cjôl le ue in tal so?». Le tiarze sivilade...
’O voi daûr di là ch’e àn sivilât. In tal prât di Dell’Olio al è un morâr, e
’o jôt une fèmine sintade su chist morâr che si ten sù sun dun branc. Chiste
fèmine ’e ere dute vistude a neri, cu li’ gjambis a pendolon e cui pîs luncs
e a spiz... ancje chei neris. Chiste fèmine mi cjalave e mi cucave, di ca e
di là dal branc, fasint dondolâ li’ gjambis. Mi soi fermade a cjalâ par un biel
toc chê fèmine dute nere. Mi veve sivilât par che le cjali e cumò no mi diseve
nuje... Chê fèmine grande e dute nere, ch’e jere di sigûr une fade, ’e cuntinuave
a cjalâmi dondolant chê’ gjambis cui pîs a spiz e fasint cucuc di ca e di là
dal ramaz. Jo no ài cjapade paùre e, dopo un toc che le cjalavi, judût che chê
fèmine no mi diseve nuje, ’o ài saltade le fuissute e mi soi inviade viars cjase.
Conch’o soi un biel toc indevant, pensant a chê strane figure, mi soi dizzidude
di tornâ a jòdile. SAN ZORZ